di Marco Radaelli
Originario di Como, ha conseguito la Laurea Triennale e Magistrale in Fisica all’Università degli Studi di Milano. È al terzo anno del Dottorato in Fisica al Trinity College di Dublino, in Irlanda, nel gruppo di ricerca di Teoria Quantistica dell’Informazione.
In terza elementare, la maestra ci aveva fatto scrivere il tradizionale tema “Che cosa vorresti fare da grande?”. Forse influenzato dal venire da una famiglia di fisici, avevo scritto che mi immaginavo in un’aula universitaria a fare esperimenti con una tanica di azoto liquido: insomma, volevo fare il fisico. Non so bene che idea avesse il me di otto anni di cosa fosse la fisica o l’università, però posso dire che, tutto sommato, ora sto realizzando quello che avevo sognato allora. Ogni tanto mi capita di pensarlo: accidenti, sto davvero facendo quello che sognavo fin da piccolo! Chi è un fisico? Nella mente di molti, credo coesistano due immagini: quella lontana degli
anni delle superiori e dei problemi sul piano inclinato, e quella più recente resa popolare da serie come The Big Bang Theory. Da un lato, una materia scolastica ampiamente detestata dai più, spesso vissuta come lontana dalla vita quotidiana e zeppa di formule da imparare a memoria, dall’altro queste immagini di uomini tanto capaci di concepire incredibili teorie sull’origine dell’Universo quanto non in grado di evitare una buccia di banana.
È da un sacco di anni che vivo in mezzo a fisici, tanto che lo sono diventato persino io, e vi posso assicurare che nessuna di queste due immagini corrisponde al vero. Se proprio vogliamo dare una definizione, direi che un fisico si occupa della realtà dal punto di vista dei suoi costituenti più elementari, e usa la matematica come linguaggio e strumento per la comprensione del mondo. Il fisico moderno nasce nel Seicento con Galileo, e da allora si occupa di un po’ di tutto: dal moto dei corpi alla temperatura, dalla luce alle radiazioni, da protoni e neutroni alle galassie. Due sono le caratteristiche che rimangono costanti: l’attaccamento alla realtà (che impedisce al fisico più teorico di sfumare nella pura matematica) e la matematica come linguaggio (che distingue la fisica più speculativa dalla filosofia). In tempi più recenti, i fisici si dividono, più o meno, in due o tre grandi branche: la fisica sperimentale (il fisico “da laboratorio”), la fisica teorica (“da lavagna”) e quella computazionale (“da computer”). Queste distinzioni esistono più nella definizione delle classi di concorso che nella realtà, dove tutto è più sfumato. Bene, quello che vorrei raccontarvi qui è il mio viaggio in questo mondo. Una delle mie frasi preferite è che studiare qualcosa è una forma di amore per quella cosa. Ma come si fa ad innamorarsi di quella materia arida, zeppa di formule, di infernali congegni, di carrucole, di astruse onde sulle corde e di gatti nelle scatole? Io credo di essermi innamorato dello sguardo del fisico sul mondo, che mi ricorda un po’ quello che immagino di vedere sul me stesso di cinque anni quando mi hanno portato a vedere gli aerei per la prima volta. Uno sguardo con gli occhi spalancati, come a voler tirare dentro una realtà troppo enorme, che dentro non ci sta. Penso che lo sguardo del fisico nei confronti della realtà sia, o possa essere, questo: il fisico ha la straordinaria opportunità di essere un curioso di professione. Ed essere curioso, alla fine dei conti, significa proprio essere innamorato. A rischio di essere un romantico privo di concretezza, direi anche che proprio questo è il contributo più grande che un fisico può portare al mondo. Certo, può lavorare per migliorare il funzionamento della macchina per fare una TAC, o per miniaturizzare i transistor del vostro telefono, o per prevedere e combattere gli effetti del cambiamento climatico, ma soprattutto porta in giro questo sguardo curioso. E coltivare questo sguardo curioso vuol dire ricordare agli uomini e alle donne che vivere e sopravvivere sono due cose diverse. Vale la pena avere persone che dedicano la loro vita a questo, e a me piacerebbe tanto dedicarvi la mia.
A otto anni volevo fare il fisico perché i miei, fisici anche loro, ogni tanto sul divano alla sera mi raccontavano come funzionavano gli atomi, o le radiazioni, o il Sistema Solare, e questo mi ha fatto innamorare. Ma le storie d’amore, si sa, sono cose complicate. Dunque, settembre 2016, finito il liceo a luglio, entro per la prima volta dal cancello del Dipartimento di fisica della Statale di Milano, in quella che sarebbe diventata, per i successivi cinque anni, la mia seconda casa. Al contrario che nella maggior parte delle storie d’amore, con la fisica di solito le cose difficili arrivano subito, e quelle più belle dopo. Nessuno si iscrive a fisica per studiare il
pendolo, o come si muovono le molle. Tutti, io incluso, arrivano zeppi di idee e sogni sui buchi neri, la teoria delle stringhe e la meccanica quantistica. E qui, fisica ti prende a bastonate. Passi un anno e mezzo a studiare quasi solo pendoli, molle, carrucole e dintorni, insieme ad una montagna di matematica che sembra messa lì apposta per scoraggiarti. Vi posso assicurare che all’epoca non la pensavo certo così, però quell’inizio è importante,
perché ti dà una potente iniezione di umiltà. Arrivi qui pensando ai buchi neri, e invece no, passi un anno e mezzo a fissare il pendolo che va avanti e indietro. Solo allora cominci, pian piano, l’avventura nella fisica moderna, e in effetti le cose si fanno divertenti. O forse, nel mentre hai imparato a innamorarti anche di quel pendolo, e hai imparato a farti domande che non ti saresti aspettato. Una cosa bella di quei pomeriggi interminabili a contare (letteralmente) novecento oscillazioni di un pendolo, è che cominci a farti degli amici. E la vicinanza di Cesare, la determinazione di Martina, la saggezza di Giorgia, la finezza di pensiero di Tommaso, e tanti altri, sono quelli che mi hanno fatto attraversare questo periodo. Dal terzo anno in poi, la bellezza della fisica straborda. Anche se in quel momento, preso tra gli esami, la vita da pendolare e gli appunti da copiare non te ne accorgi, passi da una lezione sui buchi neri e la dinamica delle galassie ad una sull’interno dell’atomo e su come è fatto un protone. A ripensarci, uno dovrebbe passare quegli anni a bocca aperta. Due tesi e una pandemia dopo, mi trovo alla fine della Magistrale; mi guardo intorno e trovo un posto di Dottorato a Dublino, in Irlanda. L’argomento è vicino a quello della tesi, si chiama Teoria Quantistica dell’Informazione. La sensazione che ricordo è quella di essere tornato all’inizio: all’inizio del cammino di lenta ma costante salita del dottorato, ma anche all’inizio della vita in un altro Paese, di cui mi accorgo di conoscere la lingua molto meno di quanto mi sarei aspettato. Mi piace molto pensare che la ricerca sia una questione artigianale. Ci sono, sì, delle tecniche comuni e delle linee guida, ma di fatto per la maggior parte sei da solo, tu e quel problema che all’inizio non si capisce neanche tanto bene. E il dottorato è l’apprendistato di questo speciale artigianato: uno scienziato esperto ti affianca, ti supporta (e spesso sopporta) nelle tue peregrinazioni. Dicono che il tuo supervisor rimanga una delle persone più importanti della tua vita, e non stento a crederlo. Fino ad ora, ho imparato che fare ricerca, spesso, vuol dire imparare a sopportare la frustrazione. Il fatto che quell’unico risultato che viene richiede mesi di tentativi falliti e di pensare che non ce la farai mai. Ma l’emozione di quando vedi comparire, sullo schermo o sulla carta, qualcosa che sei il primo a vedere nella storia dell’umanità, quando sei il primo a capire una piccolissima cosa che nessuno prima aveva esplorato, quella è un’emozione colossale. Che ti ricorda di spalancare gli occhi, che la realtà è una cosa grande, e di cui il me del tema di terza elementare sarebbe tanto, tanto felice.
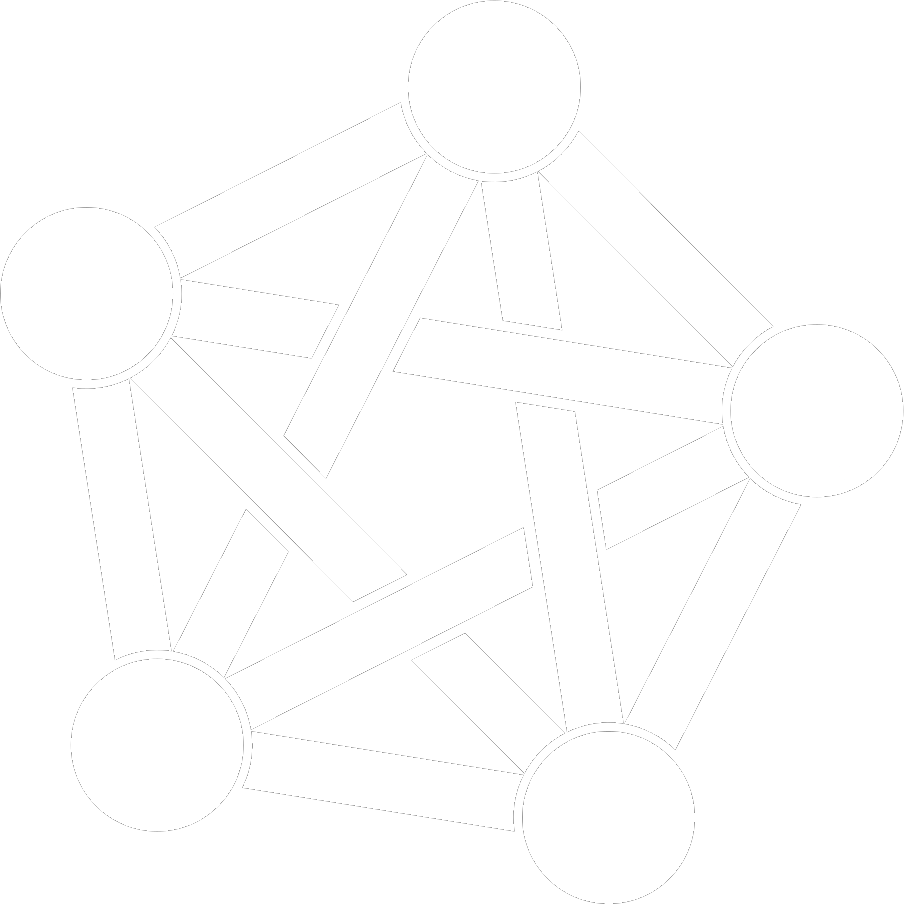
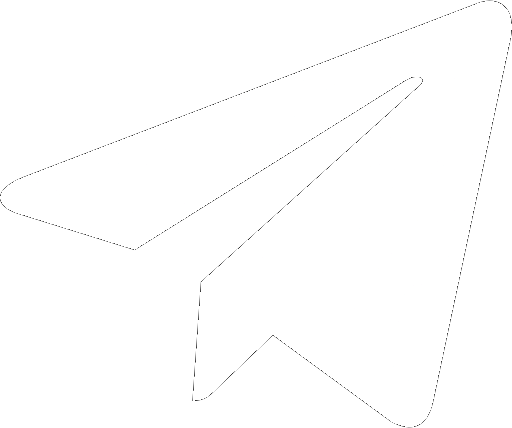




Scrivi un commento