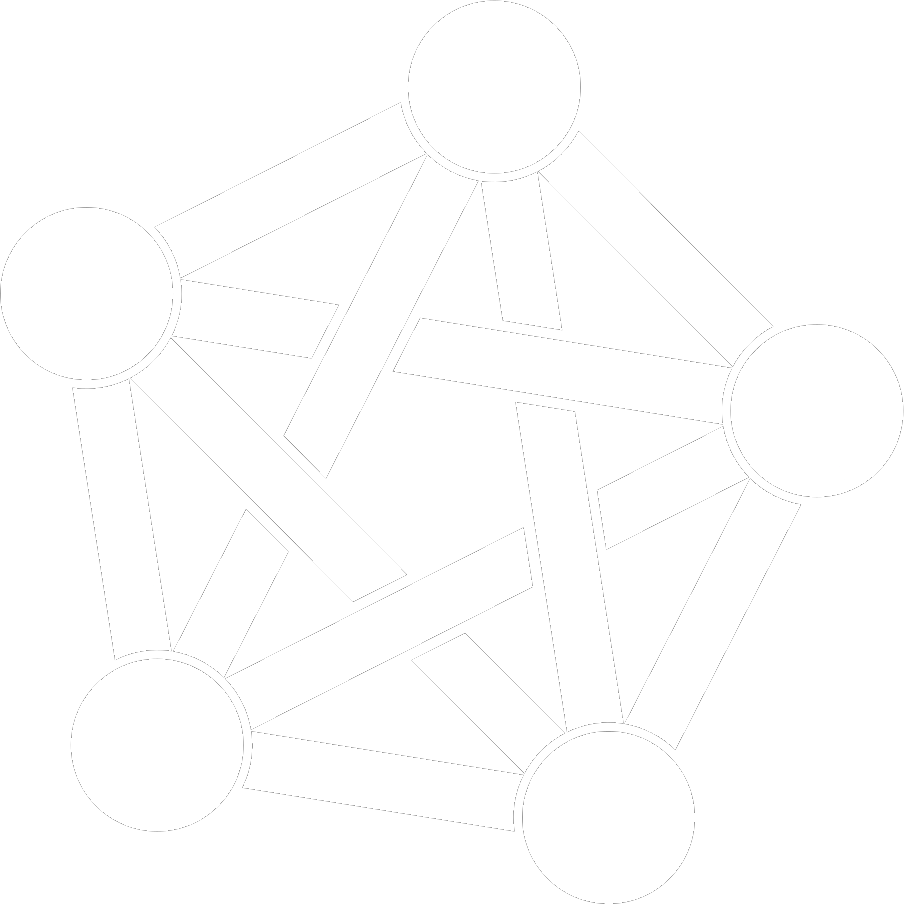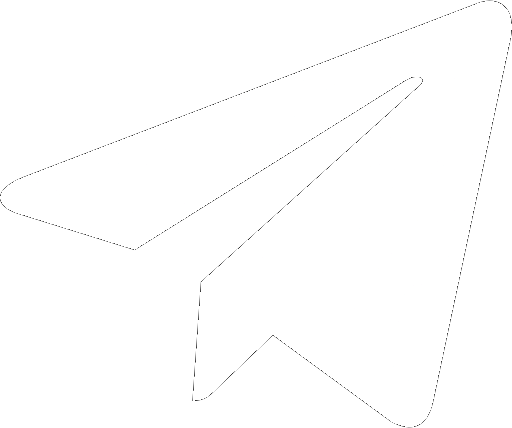di Salvo Palazzolo *
Una sera di inizio settembre, poco dopo l’ora di cena, telefonai a don Pino Puglisi per preparare il consueto incontro settimanale della Fuci. All’epoca, ero il responsabile del gruppo di Palermo, e don Pino era il nostro assistente. Mi disse quasi subito: «Quest’anno non sarò con voi, dovrete cercarvi un altro assistente». Gli risposi: «Troveremo il modo di far conciliare tutti i suoi impegni con la Fuci». Non disse altro. Mi chiese com’erano andati gli esami per la scuola di giornalismo di Milano. E aggiunse: «Ma vuoi davvero andare via dalla Sicilia?». Poi, fece una lunga pausa.
Sette giorni dopo, ero già a Milano per l’ultimo colloquio alla scuola di giornalismo. Dalla stazione telefonai a un amico. Mi disse che avevano sparato a don Pino. E ripensai subito alle parole che mi aveva detto qualche giorno prima: «Quest’anno non sarò con voi». Sapeva di aver intrapreso una strada senza via d’uscita. E non si era mai tirato indietro. Ma quella sera, a Milano, piansi soprattutto per non aver compreso cosa era accaduto in quei mesi a Brancaccio. Non avevo compreso le parole di don Pino, quelle della sera di settembre, e tutte le altre.
L’esperienza in un quartiere come Brancaccio, allora roccaforte di Cosa nostra, era iniziata quasi per caso: tre anni prima, quando il nostro assistente era diventato parroco di San Gaetano. Un pomeriggio, venne in riunione, nella sede del pensionato universitario San Saverio, e disse con il suo sorriso di sempre: «Andiamo tutti a Brancaccio. Faremo le nostre riunioni lì per qualche tempo. Dobbiamo coinvolgere tanti giovani universitari. Ce ne sono molti anche lì, cosa credete». E così il gruppo si trasferì a Brancaccio. Per qualche tempo, solo per una delle due riunioni settimanali. Poi, fra il ’92 e il ’93, la Fuci si trasferì del tutto nella difficile periferia palermitana. E alle nostre riunioni partecipavano anche diversi universitari della zona, ragazzi a cui Puglisi teneva molto. Perché erano figli di famiglie davvero particolari, che portavano un cognome pesante: dopo aver iniziato il cammino con la Fuci, erano diventati i suoi collaboratori più stretti, impegnati in varie attività di animazione in parrocchia, soprattutto con i più piccoli.
Intanto, ascoltavamo le parole del nostro assistente-parroco. Ci stupivamo sentendolo parlare dall’altare. Diceva: «Io so che l’ultimo attentato al cantiere della parrocchia è rivolto a me. Io so anche che voi siete figli di questa chiesa, qui siete stati battezzati. Le porte della chiesa resteranno sempre aperte per voi. Vi aspetto. Parliamone». Parliamone? Un parroco che invita i mafiosi al dialogo? Non capivamo. Ma il dubbio fu rimandato a dopo le vacanze estive.
Non ci fu altro tempo. I sicari di Cosa nostra preparavano già l’attentato. I pentiti hanno raccontato che i fratelli Graviano avevano fretta di uccidere il parroco di Brancaccio. Leoluca Bagarella, l’alter ego del capo di Cosa nostra Totò Riina, rimproverava i Graviano: «Avete perso troppo tempo».
Perché tanta fretta di uccidere don Pino Puglisi? Perché le sue parole e i suoi inviti al dialogo erano così pericolosi? Me lo chiedo ancora.
In questi anni, come cronista di giudiziaria, ho seguito le udienze del processo ai killer e ai mandanti del delitto Puglisi. Ho intervistato l’uomo che premette il grilletto quella sera del 15 settembre 1993, Salvatore Grigoli. Sono tornato ad ascoltare i testimoni di quella straordinaria esperienza parrocchiale di Brancaccio. E ogni volta, mi convincevo sempre di più che il caso Puglisi resta aperto. Anche se era già chiuso per la giustizia, che ha poi condannato all’ergastolo i responsabili dell’omicidio. Anche se sembrava già chiuso per la Chiesa, che ha avviato il processo di beatificazione per il parroco.
Sono stati i dubbi di uno dei killer di Brancaccio, uno di coloro che Puglisi voleva raggiungere, a confermarmi che questo caso non è affatto chiuso. «Che fretta c’era di commettere quell’omicidio? E poi perché?», si sfogava dopo il 15 settembre per lamentarsi del clamore causato dall’azione di Cosa nostra.
I pentiti non hanno spiegato quale fu la causa scatenante dell’omicidio. Hanno detto di non saperlo. I processi non hanno approfondito l’argomento. Per le sentenze, il parroco è stato ucciso per il suo impegno nel quartiere. Ma quello era iniziato sin dal primo giorno di don Pino a Brancaccio. Perché dopo tre anni, i boss decidevano di dire basta?
Dopo la morte di Puglisi, i ragazzi della FUCI di Palermo hanno vissuto momenti difficili. Uno dei ragazzi del quartiere che era ormai parte integrante del gruppo, Giuseppe Carini, è diventato uno dei testimoni dell’inchiesta e del processo per l’assassinio del parroco di Brancaccio: grazie alle confidenze che il sacerdote gli aveva fatto, i magistrati hanno scoperto che don Pino era stato minacciato diverse volte negli ultimi mesi. Ma lui aveva alzato un muro. E soprattutto, non aveva voluto coinvolgere nessuno dei suoi collaboratori in quel cammino difficile.
Anche io ho deposto al processo in corte d’assise, ma per me era diverso. Giuseppe era uno dei figli più conosciuti di una certa Brancaccio, un tempo andava a giocare a pallone con uno dei fratelli Graviano. Ma con Puglisi aveva fatto la sua scelta, anche se il giorno della prima manifestazione antimafia nel quartiere, organizzata proprio da Puglisi, aveva preferito restare a casa. Nei giorni successivi alla morte di don Pino, Giuseppe è stato invece uno dei primi a parlare con i magistrati.
Ricordo ancora l’atmosfera pesante al processo, con i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, gli uomini delle stragi Falcone e Borsellino, attenti a prendere appunti dopo i racconti di ogni testimone. Ci sarebbe piaciuto avere la Curia parte civile in quel processo. E invece, nessuno si è mai costituito.
Ci sentivamo soli in quei giorni. Smarriti più che mai. Ma nessuno dei ragazzi di Puglisi si è tirato indietro per aiutare la giustizia a fare luce sul suo martirio.
Però, un profondo senso di colpa continuava a stringere i nostri cuori. Non avevamo compreso le parole del parroco, che alle riunioni ci parlava del sistema mafioso a Brancaccio e della necessità di elaborare un piano di analisi e poi di intervento per fronteggiare la subcultura mafiosa, l’humus dell’organizzazione Cosa nostra.
Quel gruppo Fuci si è poi sciolto, e in quei mesi in cui tanti, all’interno della Chiesa e della società, facevano a gara per proclamarsi «grandi amici di don Pino Puglisi», nessuno di noi ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche. Forse, abbiamo sbagliato a chiuderci nel nostro dolore. Ma sono sicuro che ognuno di quei ragazzi della Fuci non ha mai smesso di cercare la verità sulla morte di don Pino: così abbiamo provato a trasformare il senso di colpa in una nuova riflessione e nuove analisi sulle parole profetiche del nostro assistente. Parole sulla speranza e sulla sete di verità e giustizia.
Don Pino Puglisi fu il primo sacerdote a rivolgere parole di speranza agli uomini della mafia di Brancaccio. Fino ad allora, la Chiesa aveva solo condannato i boss, così come aveva fatto ogni altra istituzioni civile. Anche Puglisi continuava ad avere parole di fuoco per la mafia-struttura di peccato, ma aveva parole dolcissime nei confronti degli uomini del crimine. Quelle parole avevano già aperto il cuore di qualcuno a Brancaccio. Quelle parole stavano per causare una voragine dentro l’organizzazione criminale.
Il natale prima dell’assassinio, il parroco inviò una lettera ai detenuti dell’Ucciardone. Poi chiese di poter tenere le riunioni delle missioni popolari nelle case dei carcerati: le moglie e le figlie dei detenuti accolsero subito il suo invito. Per la prima volta, avevano un punto di riferimento e di speranza.
Per questo è morto don Pino Puglisi, perché aveva annunciato il futuro nel quartiere che futuro non doveva avere.
«Siete figli di questa chiesa, qui siete stati battezzati. Vi aspetto». Quando diceva queste cose don Pino aveva già fatto germogliare nell’animo della sua gente di Brancaccio la fame e la sete di giustizia. Si aprivano sempre più, poco a poco, ma oramai irreversibilmente, i cuori di chi per decenni aveva fatto della rassegnazione il proprio destino e dell’omertà uno stile di vita.
Come ogni buona notizia questa aveva fatto in fretta il giro del quartiere. Un passaparola prima sommesso, timido per ogni porta della borgata. Poi gridato forte in ogni via. «Cercate innanzitutto il Regno di Dio e la sua giustizia e le altre cose vi saranno date in più», spiegava padre Pino cercando, giorno dopo giorno, di far crescere il seme del cambiamento: «Se questa beatitudine diventa vita personale — annunciava — si realizza ciò che diceva il profeta Geremia: Tutti mi riconosceranno, dal più piccolo al più grande perché io perdonerò la loro ingiustizia e i loro peccati non li ricorderò più». Misericordia, perdono, accoglienza, amore. Le parole che hanno fatto paura alla mafia, che le hanno fatto temere che il suo regno di morte potesse vacillare. E che dicono del significato più profondo del martirio di Giuseppe Puglisi.
Leggeva e rileggeva don Pino la pagina evangelica di coloro che sono beati perché hanno fame e sete di giustizia. Alle riunioni, diceva che era la pagina del Vangelo che amava di più, che aveva scoperto da ragazzo quando aveva sentito la chiamata del Signore.
Qualche mese prima di morire tenne uno dei suoi ultimi campi scuola vocazionali. Anche qualche ragazzo della Fuci partecipò. Agli adolescenti con cui trascorse in riflessione qualche giorno, propose di entrare sin dentro lo spirito della beatitudine. Ecco il discorso della montagna nel cammino di Pino Puglisi: «Bisogna farla sorgere la fame e la sete di giustizia — disse — poi bisogna aiutarla a trovare la propria strada».
Nell’animo della sua gente di Brancaccio così faceva germogliare la voglia di cambiamento: «Gesù ha voluto dirci — spiegava il parroco — che la giustizia deve essere qualcosa che ognuno di noi sente profondamente come ciò di cui non si può fare a meno; che costituisce la nostra stessa natura, un bisogno insopprimibile, come la fame e la sete che vengono dall’intimo dell’uomo. Giustizia, nel linguaggio di Gesù, significa ricerca interiore ed esistenziale della volontà di Dio». E nei pensieri di Dio, ne era certo don Pino, c’era anche la schiavitù della sua gente di Brancaccio: «Nel cristiano — spiegava — il senso della giustizia è l’amore verso tutti. Quello che cercava di vivere Gesù, dando un orientamento alle persone, preoccupandosi dei loro bisogni. Per dare un senso alla vita — concludeva — è necessario conoscere le molte cose che creano quella giustizia e quell’equilibrio che si possono riassumere nel comandamento: “Ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore, ama il prossimo tuo come te stesso”».
* Giornalista e già Presidente del gruppo FUCI di Palermo