Tra rinnovamento e memoria: la FUCI dopo il Concilio Vaticano II
Qui di seguito riportiamo un’intervista al prof. Marco Ivaldo, già Presidente Nazionale, e a Thierry Bonaventura, già Condirettore di Ricerca, cercando di analizzare il Concilio Vaticano II, sotto una lente differente, come aggiornamento nella vita dei cattolici.
Quale impulso il Concilio Vaticano II ha dato al ruolo della Federazione all’interno della Chiesa? E nella società?
Marco Ivaldo: Premetto che io sono stato Presidente dal 1970, in FUCI dal ‘68.
Alcuni temi del Concilio erano presenti già nell’esperienza della FUCI, che anticipò in alcuni aspetti quella stagione di rinnovamento, come ad esempio rispetto al problema dell’identità del laico. Il Concilio ha poi agito sulla FUCI come un impulso di ripensamento della sua forma d’essere.
La FUCI entrava in un periodo di forte crisi identitaria; negli anni 70 si era arrivati allo scioglimento di molti gruppi come conseguenza della crisi ideale profonda che il Concilio aveva provocato nei cristiani. Il Concilio proponeva una forma d’essere nuova per il cristiano, che aveva come spunto i quattro documenti fondamentali: la costituzione Dei verbum sul primato della parola. Non si comprende la FUCI di quegli anni, se non attraverso la consapevolezza del primato della parola di Dio. Secondo documento: la Sacrosantum concilium sulla liturgia e l’eucaristia come momento fondamentale nella storia personale di fede. Terzo, la Lumen gentium, sulla Chiesa intesa come comunità e popolo di Dio in cammino e non più come società perfetta. Quarto documento: la Gaudium et spes, sulla presenza della Chiesa nel mondo. In questo documento si affermava la fondamentale convergenza della Chiesa e dell’umanità e l’identità delle gioie e delle angosce dell’uomo con le gioie e le angosce della Chiesa.
La sfida intellettuale che occupava quegli anni era quella di riconoscersi in una fondamentale appartenenza all’umano per comprendere nuovamente il nostro essere cristiani. Le forme tradite di autocomprensione della fede non venivano considerate più sufficienti, occorreva ricercare nuove risposte alla domanda fondamentale su chi eravamo.
Thierry Bonaventura: Se lo scopo è far capire alle nuove generazioni cosa è stato il Concilio Vaticano II, il giusto approccio è leggere questa stagione di vita della Chiesa attraverso il termine “aggiornamento”.
La FUCI si è sempre inserita tra profezia e tradizione, tra memoria e ricerca, anticipando alcuni elementi di quella stagione.
Una delle dimensioni proprie della FUCI è di essere una realtà locale, il concilio ha rivalorizzato la funzione della chiesa particolare rispetto alla Chiesa di Roma, la chiesa particolare dalla quale sussiste l’unica Chiesa. La domanda da porsi è: questa nuova ecclesiologia ha avuto un suo riscontro a livello di gruppi?
C’è stata la scoperta della localizzazione necessaria, spesso noi utilizzavamo nelle nostre riflessioni l’espressione “chiesa locale”, una chiesa cioè radicata in un certo luogo. Ci fu una dialettica tra unità e località della Chiesa italiana animata dalla Federazione, e questo rappresenta un interessante aspetto di quegli anni. Per comprenderne pienamente le ragioni bisogna contestualizzare il comportamento della FUCI nella Chiesa e anche nella società italiana, alla fine degli anni 60. Erano anni questi in cui la società italiana subiva profonde trasformazioni, il miracolo economico degli anni 50 esigeva ora un salto di qualità politica e sociale.
La FUCI ha sempre scelto di cercare di costruire dalle università nuovi modelli culturali e scientifici per affrontare queste trasformazioni sociali.
Rispetto a quali temi la FUCI fu capace di guardare con fiducia alla modernità?
Marco Ivaldo: Rispetto a due temi soprattutto. Il primo, il riconoscimento del valore strutturale della libertà. Il secondo, il tema della coscienza. Si tratta di due temi costitutivi della storia federativa. Solo nella libertà ci si può rivolgere alla verità. La libertà della fede implica una scelta, quindi un rapporto dialettico tra un possibile sì e un possibile no. Questo aspetto ci avvicinava e permetteva di incontrare il pensiero moderno. Allo stesso tempo eravamo però attenti a coltivare un’adesione selettiva alla modernità.
Altro aspetto della modernità che insegnava il Concilio era il valore della storia.
La fede cristiana ha una storia perché il rapporto tra Dio e la creatura si declina sempre in alcuni fatti, cioè appunto in una storia. Questo tema ci invitava a riconsiderare complessivamente il patrimonio vivo della fede colto nel suo essere storia di fatti di libertà.
In questo senso direi che la storicità era un termine ricevuto dalla cultura moderna a cui però davamo una nostra interpretazione.
Un’altra parola chiave era autonomia, intesa come il riconoscimento del fatto che le scienze e le arti avevano una loro indipendenza, delle loro leggi e dei valori propri che l’intelligenza aveva il compito di scoprire e rispettare. Era fondamentale riconoscere che la città temporale aveva una sua relativa autonomia e che questa, come ogni cosa della creatura umana, era fondata su principio della libertà.
Thierry Bonaventura: Lo sguardo di fucino di metà degli anni 90 era sguardo di disincanto rispetto al Concilio Vaticano II. Si parlava ancora di ricezione, ma qualcuno voleva già il Concilio Vaticano III. Era chiara la consapevolezza di essere Chiesa di un Concilio non pienamente compiuto, mancava ancora qualcosa, anche in termini di pastorale degli ambienti. Era ad esempio necessario capire come abitare l’ambiente universitario.
Il cambiamento epocale che il Concilio aveva sancito rispetto al tema dell’ecumenismo era chiaro, eppure quasi 25 anni dopo non c’era ancora una comunione reale. I fucini degli anni novanta guardavano come riferimento ancora ad autori quali Maritain, Harent, Paul Ricoer, ma sembrava mancare un maestro che aiutasse ad avere una visione più globale.
Si stava delineando un progetto chiaro di Chiesa e di società, e i fucini che erano i bravi giovani, preparati, intellettualmente vivaci, avevano però poca incidenza nell’ambito universitario e in ambito sociale.
Chi entrava in FUCI lo faceva per fare un’esperienza di Chiesa, per maturare nella fede, non accontentandosi delle risposte che la semplice catechesi e la vita dei fedeli gli poteva offrire. Era però questo anche un momento di forte ricambio generazionale: non vi erano più testimoni diretti della stagione conciliare, laici e assistenti appartenevano ormai alla generazione del dopo-concilio.
Come si concretizzava il rapporto tra l’identità cristiana dei giovani della FUCI e l’autonomia della laicità degli studi? Quali erano i modi per elaborare un pensiero culturale capace di rispondere alle istanze della modernità?
Marco Ivaldo: Rispetto alla spiritualità universitaria, la Federazione basava il modo di atteggiarsi della coscienza della persona e dello studente su un principio cardine: la parola di Dio. Le settimane di Camaldoli erano dedicate all’esegesi della parola di Dio. In quegli anni ho percepito questa centralità della parola di Dio come cristocentrismo, più che teocentrico.
Altro aspetto della spiritualità dell’universitario era una pratica laica dei saperi scientifici. Il fucino doveva entrare in università con un’identità radicata nella Parola, ma con un’apertura strutturale alla sfera del mondo e del sapere.
Questo momento specifico di apertura al campo delle scienze e dei saperi si incontrava con un impegno sociale e politico in una società pluralista che stava cambiando e in cui non si poteva dare più per scontato il consenso intorno alle verità cristiane. Stava cambiando la società secolare, rispetto a cui la Fuci doveva ricentrare sé stessa per poter avanzare una proposta di natura politica e sociale ispirata alla fede.
Thierry Bonaventura: Rispetto al tema della spiritualità, la parola di Dio è rimasta sempre al centro. La liturgia delle ore era un modo pratico per aiutare lo studente universitario.
Il Concilio aveva ricentrato fortemente la Chiesa su Cristo, ma la Chiesa era anche dello Spirito. Il dialogo con i nuovi movimenti sorti nella metà del secolo che accentuavano questo secondo aspetto innescò nella FUCI una nuova riflessione rispetto a questo tema.
La Federazione era molto dibattuta tra il desiderio di testimoniare in un ambiente universitario non più cattolico e la fatica di affrontare il tema politico in modo tale che potesse trasformarsi in una progettualità politica.
Allo stesso tempo si faceva avanti l’idea di una nuova forma di diaconia, della responsabilità che i fucini potevano assumere nell’ambito ecclesiale una volta lasciata la federazione. Nasceva ad esempio la consapevolezza della necessità di una forma di diaconia nella cultura.
Ai miei tempi organizzavamo delle settimane volte alla formazione delle persone che ricoprivano un incarico federativo. C’era la percezione dell’importanza della leadership, di far maturare un approccio diverso al gruppo in termini organizzativi. La necessità di formare dei quadri per la Federazione era molto sentita, perché si capiva che il tessuto umano e sociale stava cambiando, che il giovane degli anni ‘90 non era il giovane degli anni ‘40-‘50 e che era necessario affrontare questi cambiamenti.
La stagione conciliare ha determinato anche un ripensamento delle forme, un desiderio di modificare la struttura della federazione?
Marco Ivaldo: La spinta conciliare ha sollecitato e valorizzato la dimensione democratica e partecipativa della FUCI. L’essere parte attiva di una vita associativa, attraverso il dialogo e il confronto su un progetto comune, attraverso il riconoscersi in un patto tra eguali, era il sale della nostra esperienza democratica. Non c’è stata in quegli anni molta attenzione a modifiche statutarie. Noi avevamo un problema fondamentale, ovvero rispondere a una domanda rispetto al mondo: “Chi sei tu cristiano? Quale è la tua pretesa di verità?” Vivevamo in una società in rapidissima trasformazione e vi era esigenza di rispondere alla domanda sull’essere della fede in questo contesto. “Il Figlio dell’Uomo troverà ancora fede sulla terra?” questo il quesito che ci assillava. L’importante era dunque mantenere aperta la federazione come esperienza partecipativa e democratica nella quale vi era l’eguaglianza tra uomini e donne che godevano delle stesse facoltà di decisione e di azione.
Thierry Bonaventura: Nella mia generazione era acquisito che la presidente femminile aveva più responsabilità. In quegli anni c’è stato un piccolo cambiamento nello statuto, dovuto all’Azione Cattolica e modifiche nel regolamento dell’Assemblea federativa, per facilitare i processi decisionali.
Quando sono entrato nella FUCI, il primo articolo pubblicato aveva come titolo “Se la chiesa è società democratica o meno”. Questo era in effetti un tema che stimolava una grande riflessione. C’era la volontà di comprendere le modalità di esercizio del potere nell’ambito ecclesiale, probabilmente per una forma di discrepanza su quello che si sperimentava nell’ambito di Chiesa.
L’unica spinta democratica era per la nomina o la scelta dei candidati della presidenza che portava ad una grande discussione. A livello federativo venne, ad esempio, chiesto al Consiglio Centrale di scegliere i suoi candidati, mentre la Presidenza ufficialmente non ne presentò di suoi.
La costituzione Apostolicam actuositatem ha rappresentanto un punto di arrivo o di partenza nella riflessione sul laicato e sul ruolo delle associazioni?.
Marco Ivaldo: L’Apostolicam Actuositatem veniva considerato un documento di minore espressione profetica e programmatica rispetto alle altre costituzioni. Era un testo figlio ancora della visione ecclesiale precedente e riconosceva e definiva la dimensione apostolica del laicato all’interno di una concezione della Chiesa che non era quella promossa dalla Lumen gentium. La più attuale concezione del cristiano laico la troviamo piuttosto nel capitolo 32 della Lumen gentium. In questa è contenuta infatti una definizione sintetica del laicato molto più profonda, da un punto di vista ecclesiologico, di quella espressa nel documento dell’Apostolicam Actuositatem: l’apostolato del laico come un modo d’essere del cristiano che cerca il mondo di Dio nelle cose temporali. Si inseriva così la definizione dell’apostolato del laico dentro una componente escatologica e teologica.
Questo tema aprì molte controversie: come si doveva intendere il laico? Era necessario sostituire al termine di laico semplicemente quello di cristiano?
L’idea di base era che non ci fosse una chiesa articolata in laici o religiosi, quanto piuttosto un incontro ecclesiale dei christi fidelis nell’ascolto della parola e in vista del mondo, senza parlare esplicitamente di laico.
Di Allegra Tonnarini e Gabriele Cela
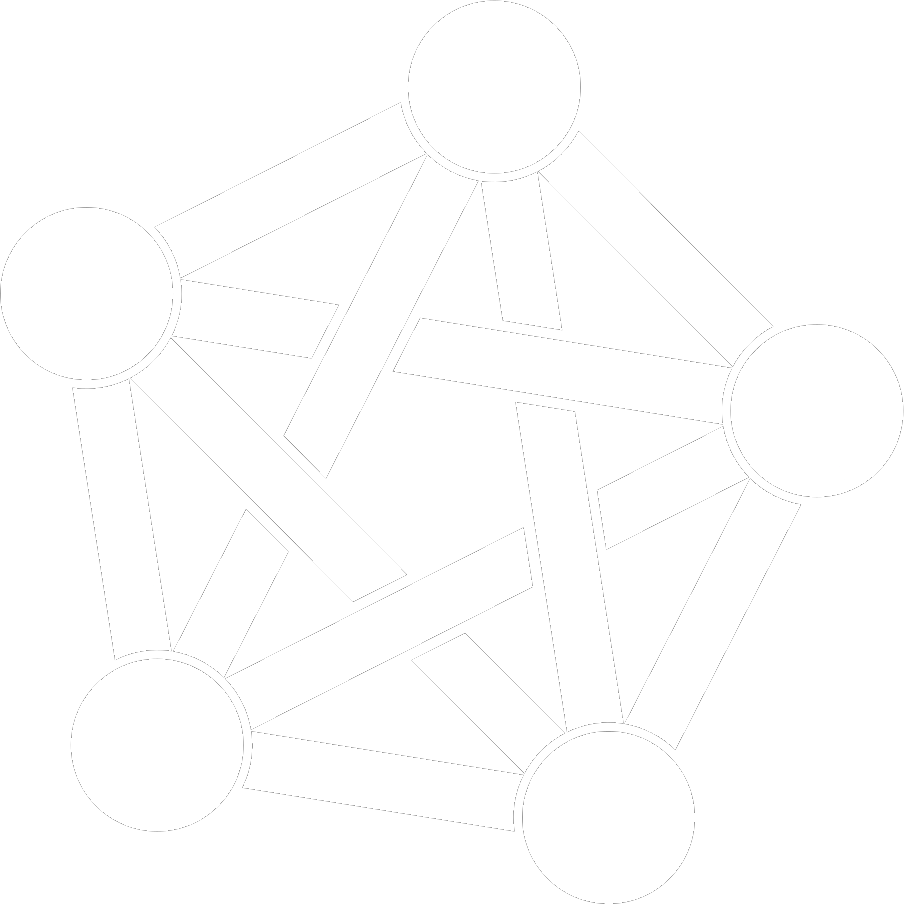
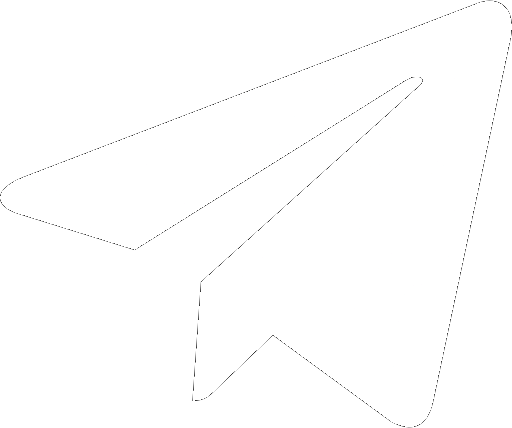







Scrivi un commento