GUERRA E PACE NELLE TRAGEDIE MANZONIANE
di Allegra Tonnarini
PRESIDENTE NAZIONALE FEMMINILE DELLA FUCI, STUDENTESSA DI FILOLOGIA MODERNA
ALL’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA
Un comandante veneziano che vive l’urto tra la “perfidia dei suoi tempi” e il suo animo «forte ed elevato»¹; un principe longobardo che assiste al declino della sua stirpe e del suo regno. Cosa accomuna i due protagonisti delle tragedie manzoniane? Non solo l’altezza tragica delle loro vicende, o il realismo storico della narrazione, ma un interrogativo profondo: come l’uomo può operare il bene in un tempo della storia iniquo.
Siamo nei primi decennai del Quattrocento. Il conte di Carmagnola guida vittorioso le truppe veneziane nella battaglia di Maclodio, ma decide di liberare i prigionieri di guerra e viene accusato di tradimento dal Senato veneziano e condannato a morte. Con un salto indietro di circa settecento anni, ci ritroviamo, con l’Adelchi, nel conflitto tra il regno di Desiderio e le truppe franche guidate da Carlo Magno che, con la conquista di Pavia, porrà fine alla stirpe dei re longobardi.
Lo scenario comune di queste vicende tragiche è la guerra, strumento di violenza della storia, che rifiuta le ragioni dei vinti e riconosce la forza degli oppressori. Una guerra, nel caso della prima tragedia, ritenuta, persino «giusta e necessaria»² dalla morale corrotta e deformata dei senatori veneziani.
Di fronte a questa malvagità dei tempi che assume i toni di una necessità storica, Manzoni ripropone il senso cristiano della vita dell’uomo: la fede “nella grazia redentrice del Cristo” che dà sempre all’uomo un’occasione di bene e di libertà morale, la possibilità di «scegliere la via della giustizia anche in una società irrazionale»³, di sperare, anche nei tempi più bui, in un sogno di pace e di fraternità tra i popoli.
Alla luce di questa premessa, è utile ripercorrere alcuni passaggi del coro de Il conte di Carmagnola che ci permettono di mettere a fuoco il binomio guerra e pace nella riflessione manzoniana. Nel coro al termine del secondo atto leggiamo:
«S’ode a destra uno squillo di tromba;
A sinistra risponde uno squillo:
D’ambo i lati calpesto rimbomba
Da cavalli e da fanti il terren»⁴.
In questo celebre incipit, Manzoni introduce la descrizione della battaglia di Maclodio. Si tratta, certamente, di uno scontro crudele, concitato, ben reso dal ritmo anapestico dei versi. Ma non solo di questo. Tra le truppe viscontee e l’esercito veneziano si consuma un conflitto ben più feroce: una guerra civile. Ma ancora di più. Una “bella plus quam civilia”: una guerra fratricida. La “guerra civile” tra due eserciti italiani è, infatti, tanto più empia perché assume i contorni di una guerra tra fratelli, tra uomini consanguinei, tra figli di una stessa terra:
«D’una terra son tutti: un linguaggio
Parlan tutti: fratelli li dice
Lo straniero: il comune lignaggio
A ognun d’essi dal volto traspar.
Questa terra fu a tutti nutrice».
E non è un caso che i versi della prima e della seconda strofa («Quinci spunta per l’aria un vessillo; / Quindi un altro s’avanza spiegato […] Già le spade rispingon le spade») richiamino i versi del proemio della Farsalia che apre il poema con i toni cupi della guerra fratricida tra gli eserciti di Cesare e Pompeo («insegne che si oppongono ad insegne ostili, aquile contrapposte, armi levate contro armi). Il coro del Carmagnola fa cadere, dunque, una dura condanna sulle guerre intestine
che affliggono il popolo italiano e che ne rendono la terra disponibile alle brame straniere. Nelle ultime strofe, però, l’autore compie un ulteriore scarto: la condanna della guerra civile passa a ogni forma di guerra, di violenza e di sopraffazione da parte di un uomo nei confronti di un altro in ragione della comune
fratellanza, dell’essere tutti figli dello stesso Padre. Secondo la prospettiva cristiana, che ci riconosce tutti fratelli e sorelle, ogni guerra è infatti fratricida:
«Tutti fatti a sembianza d’un Solo;
Figli tutti d’un solo Riscatto,
In qual ora, in qual parte del suolo
Trascorriamo quest’aura vita,
Siam fratelli: siam stretti ad un patto:
Maledetto colui che lo infrange».
Se ogni forma di guerra e di violenza è empia, se all’uomo è negata ogni ragione della forza, cosa resta dunque di fronte alla crudeltà della storia? Solo l’esser vinto e il patire. Il conte di Carmagnola è ancora un eroe guerriero, pronto a risolversi nell’azione, a dar prova della sua virtù nel campo di battaglia; con Adelchi, invece, scopriamo l’eroe dell’inazione, dell’abnegazione di sé, che rinuncia all’atto drammatico e «consegna alla parola e all’intelletto quel che gli si nega sul piano dell’azione»⁵. Il rifiuto del dinamismo storico da parte del principe longobardo è il diniego reciso all’esercizio di un potere sulla realtà che possa tramutarsi in sopraffazione e violenza a danno dei più deboli. L’eroe vinto, sopraffatto dalla storia, è per Manzoni l’unico eroe tragico possibile perché in lui si risolve il vero dramma dell’esistenza: la scoperta della finitudine umana di fronte all’assoluto, all’eterno, all’illimitato, scoperta che è d’altronde premessa alla conoscenza del bene e alla possibilità di non operare il male nella storia.
Se la riflessione di Manzoni sulla guerra è espressa con tale forza e chiarezza, suoneranno forse strane, allora, le parole della tredicesima strofa del coro:
«Affrettatevi, empite le schiere,
Sospendete i trionfi ed i giuochi,
Ritornate alle vostre bandiere:
Lo straniero discende; egli è qui».
Niente di meno che un’esortazione a combattere contro il nemico straniero, a difendere con le armi la libertà della propria patria. Non si tratta certo di un caso, o di un vezzo retorico. Siamo di fronte a una delle aporie più sofferte delle tragedie manzoniane. La consapevolezza, da un lato, che ogni azione affidata alle armi è una guerra fratricida e che non può dunque esimersi da una condanna morale, anche quando la causa è giusta e le armi sono rivolte contro l’oppressore. Dall’altra, l’esortazione agli italiani a sottrarsi al giogo straniero, a ritrovare la virtù sopita e farsi padroni del proprio destino attraverso un’azione violenta e lo spargimento del sangue dei propri oppressori. Un interrogativo irrisolto che investe la legittimità delle ragioni della guerra e dell’uso della forza nei confronti dell’aggressore.
Se, dunque, l’anelito alla pace vive di queste due tensioni inconciliabili, ciò non di meno il popolo italico del coro dell’Adelchi continua a sognare «la fine del duro servir». E per quanto la speranza sia presto disillusa e gli eventi della storia spingano con insistenza a un cupo pessimismo, nell’animo di queste genti «la volontà non rinuncia a trarre dalla conoscenza delle leggi storiche una guida all’azione, che soddisfi l’ansia di progredire – un giorno – verso una società più giusta»⁶.
- A. Manzoni, Carteggi I. Lettera al Giudici, 7 febbraio 1820.
- Id., Il conte di Carmagnola, a cura di G. Lonardi, Marsilio, Venezia 1989, p. 100.
- A. Accame Bobbio, Storia dell’Adelchi, Le Monnier, Firenze 1963, p. 9.
- A. Manzoni, Il conte di Carmagnola, cit., pp. 125-129.
- G. Lonardi, Introduzione, in A. Manzoni, Adelchi, Marsilio, Venezia 1992, p. 21.
- V. Spinazzola, Introduzione, in A. Manzoni, Inni sacri. Tragedie, Garzanti, Milano 1988, p. XXV.
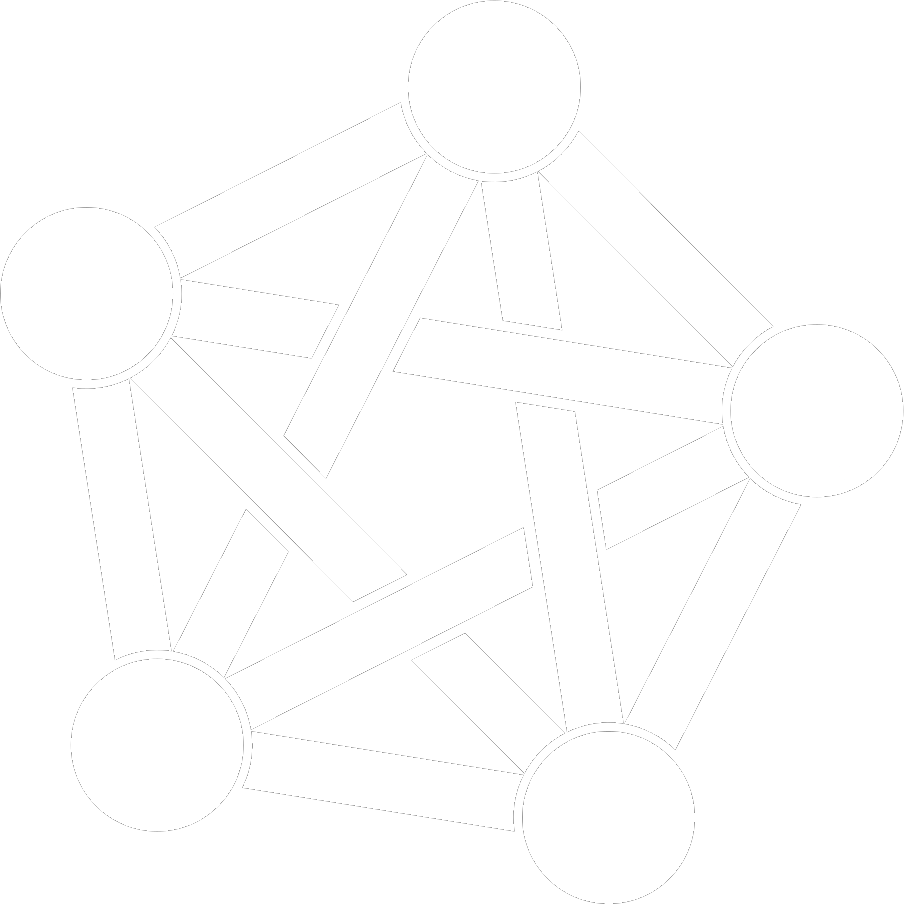
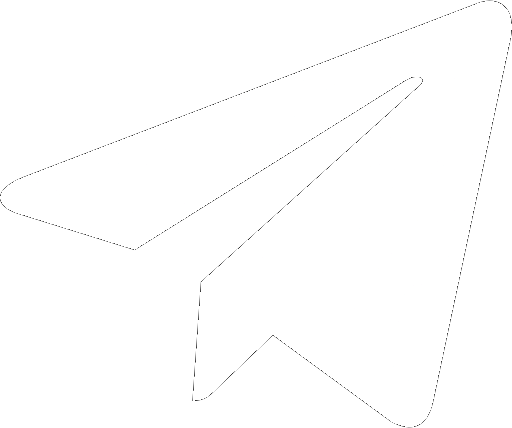







Scrivi un commento