PER SOGNARE LA PACE
di Sébastien Verney
FUCINO DEL GRUPPO DI TORINO E RAF,
STUDENTE DI FILOSOFIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
È il 1795 e viene pubblicata, in Germania, la prima edizione di Per la pace perpetua, di I. Kant¹. Prima e dopo di lui tanti si sono impegnati nella missione filosofica di dare forma all’idea di pace ma, vuoi per il contesto storico in cui l’autore viveva e scriveva, vuoi per la ricchezza del sistema filosofico in cui il progetto si inserisce, vuoi semplicemente per il valore intrinseco di quest’opera, il progetto filosofico della pace perpetua kantiana spicca su tutti gli altri con grande eleganza.
Il miglior modo per fotografare la natura del saggio è quello di definirlo come un “progetto filosofico”. Questo concetto accosta due termini di campi semantici diversi nel senso comune. Infatti, nell’accezione comune, parlare di filosofia va di pari passo con il parlare di qualcosa di astratto, legato all’elaborazione di idee, di concetti che, tendenzialmente, rimangono nell’ambito concettuale senza grandi implicazioni sulla vita pratica: filosofico è, di solito, l’atto di dare definizioni della realtà. Quando invece parliamo di progetto, sempre nella conversazione quotidiana, immediatamente ci vengono in mente ponti, case, strade, gallerie e ogni genere di infrastruttura che abbia bisogno di una pianificazione previa la costruzione. Progetto filosofico è quindi l’unione di questi concetti: l’utopia. È legittimo
chiedersi se, soprattutto dopo l’oscurità che abbiamo visto ritornare in Europa, sia sensato parlare di utopia, se sia sensato parlare di ciò che sembra irraggiungibile. La risposta ci arriva proprio dall’utopia come sogno: non solamente è sensato, ma dall’intellettuale va inteso come un obbligo professionale. Il nostro compito è pensare l’impossibilità della guerra e l’inevitabilità della pace, per poi comunicarle al mondo in maniera convincente. L’utopia come progetto filosofico permette di unire l’immenso potenziale immaginifico dell’idea con la concreta progettualità comune. Senza questo passaggio obbligato l’inevitabilità della pace non può che diventare la certezza della guerra.
Una delle prime sfide che vanno affrontate nel concepire la pace è quella della costruzione di un’ambiente che sia luogo adatto per l’avviamento di processi etici e politici virtuosi. Parlando metaforicamente, possiamo paragonare l’ambiente etico e politico di un determinato sistema alle tubature di un impianto idraulico: se le tubature sono sporche, inevitabilmente anche l’acqua che vi passa sarà sporca; ma se le tubature sono ben pulite, si ha la certezza che l’acqua che vi passa non si intorbidirà a causa loro². Questo ambiente va pensato come un’infrastruttura necessaria e previa l’avviamento dei processi desiderati. Senza di essa non si può avere, anche a seguito dei nostri sforzi più strenui, una politica che sia in grado di garantire la pace. È quindi con questo obiettivo in mente che ci approcciamo, in questo articolo, a Per la pace perpetua di Kant; analizzando alcuni aspetti dei tre articoli definitivi, cercheremo di trovare, senza pretese di completezza, i nodi cruciali che fanno da sostrato e da infrastruttura alla costruzione della pace.
1. In ogni stato la costituzione civile deve essere repubblicana
Il primo articolo tratteggiato da Kant prevede la presenza di costituzioni civili repubblicane in ogni stato nazionale. È infatti inconcepibile per il filosofo una condizione di pace se non in uno stato ove sono rispettati i valori repubblicani – e aggiungo – ove giustizia, solidarietà e sussidiarietà sono considerate valori inalienabili. Proprio per questo motivo la pace internazionale deve essere concepita come l’estensione della stabilità locale a livello globale. Dando per assodata l’assunzione fondamentale della bontà del repubblicanismo sopra il dispotismo e della bontà della rappresentatività e della corresponsabilità dei cittadini in uno stato, va introdotto un concetto di solidarietà tra stati: come i cittadini di uno stato sono chiamati a essere difensori dei diritti fondamentali di un paese, allo stesso modo i paesi dovranno essere garanti della difesa dei valori di pace e giustizia tra e verso gli altri stati. Siccome gli stati sono garanti della pace, della giustizia e di tutti i valori repubblicani all’interno dei confini nazionali, questi devono essere promotori e garanti di questi stessi principi all’interno dell’unione
degli stati sovrani.
Inoltre, la globalizzazione e l’esponenziale estensione di reti tecnologiche informazionali hanno portato un’ulteriore novità: l’impossibilità di tollerare l’indifferenza davanti alle ingiustizie. Con questo intendo dire che l’allargamento dello sguardo di coloro che hanno accesso alle Ict (Informational and computing technologies) porta con sé nuove responsabilità: chi ha la possibilità di vedere le esigenze di chi è apparentemente lontano e dunque di programmare le sue azioni consapevolmente, non può ridursi all’indifferenza. La nuova società ha assunto la forma di un panopticon³: ognuno vede tutti ed è visto da tutti. Questa capacità recentemente acquisita acuisce ancora di più la chiamata alla solidarietà fra stati, divenuta ormai una necessità della politica internazionale. Va quindi superata la dinamica di sfruttamento delle difficoltà e delle ingiustizie, che si instaura tra democrazie e paesi con difficoltà sociopolitiche interne. È inevitabile pensarci corresponsabili come individui e come stati nella corsa verso il benessere globale, che non significa rendere tutti ricchi allo stesso modo, o ridistribuire i beni equamente, ma significa costruire e finanziare azioni solidali che promuovano l’avviamento di processi e la costruzione di sistemi e governi giusti, piuttosto che rimpinguare le casse di governi dispotici e violenti, per il solo fine del benessere dei pochi.
2.Il diritto internazionale deve fondarsi su un federalismo di liberi stati
Vestfalia, 1648; è appena terminata una delle più oscure parentesi di conflitti sul suolo europeo. Viene stipulata una pace che, oltre a garantire stabilità internazionale, vede l’affermarsi definitivo degli stati sovrani e nazionali, al cui interno il potere è ben equilibrato e suddiviso tra istituzioni statali (poteri legislativo, esecutivo e giudiziario) e non più nelle mani di classi sociali indipendenti e contrastanti (clero, nobiltà, popolo). Bretton Woods, 1944; è appena terminata la Seconda guerra mondiale. Viene sancito e definito un nuovo ordine monetario e commerciale destinato a governare i rapporti tra stati indipendenti, dando così origine a un ambiente che permette la nascita di organizzazioni economiche internazionali.
Oggi, l’affermazione di agenti politici internazionali, come le grandi aziende e multinazionali, diventa problematica se si cerca di costruire un ordine internazionale. Questo perché? Innanzitutto le attuali politiche internazionali faticano a includere le grandi aziende nel novero degli enti che vanno normati: il diritto internazionale spesso non concepisce come sufficientemente chiara la similitudine tra il potere di uno stato e quello di un’azienda. Inoltre, consapevoli che è primariamente l’uomo a determinare le costruzioni sociali e non il contrario, bisogna essere consci che le dinamiche di mercato che fanno da filtro di lettura degli sviluppi delle relazioni tra stati sono elementi di determinazione sociale, al pari di tanti altri. Con questo si intende dire che le relazioni internazionali non sono di per sé regolamentate come un mercato, ma è per il fatto che le leggiamo sotto questa luce che le facciamo essere tali. Nonostante ciò, troppo spesso, vengono istituiti programmi e politiche internazionali come se le dinamiche politiche non fossero altro che dinamiche economiche. Chiaramente però, nel momento in cui si afferma questa visione della scena politica internazionale assimilata a un mercato, si instaurano dinamiche di guadagno e sfruttamento incompatibili con la sussistenza di una pace internazionale perpetua.
Ciò che è richiesto dal nostro tempo, l’appello urgente del mondo intero verso coloro che guidano gli stati e le aziende, è di smettere di pensare le dinamiche di mercato come necessarie e caratteristiche dell’agire politico, convertendo l’azione e la progettualità internazionale verso una consapevole e sostenibile corresponsabilità verso il bene comune.
3. Il diritto internazionale deve essere limitato alle condizioni dell’ospitalità universale
Nell’articolo terzo si parla di ospitalità universale come elemento liminare del Diritto internazionale. Il principio di ospitalità descritto da Kant si colloca esplicitamente su un piano differente rispetto al principio di accoglienza: gli stati hanno il dovere di accogliere gli stranieri che lo richiedano, solo a condizione che questi rispettino l’ordine interno dello stato. Però, l’aspetto più interessante di questo articolo è il sostrato teorico che sta alla base del principio di ospitalità. Cosa garantisce l’ospitalità tra i paesi? La condizione necessaria affinché sia possibile parlare di accoglienza nei limiti del rispetto della legge dello stato è il mutuo e diffuso riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo. La nostra stessa capacità di poter parlare di ospitalità deriva necessariamente dal nostro comune linguaggio di mutuo riconoscimento: se non riconosco che i confini condivisi della mia umanità e dell’umanità dello straniero valicano e trascendono i confini degli stati, non potrò mai avere né l’ospitalità, né tantomeno la pace.
Introduciamo una ulteriore distinzione per concludere la nostra breve riflessione sulla pace. Tentando di realizzare l’utopico progetto della pace, soprattutto se lo si fa nella Chiesa e a partire da essa, vanno distinti i concetti di giustificazione e motivazione.
La prima va intesa come il minimo comun denominatore che sta alla base di un’azione condivisa: quella ragione che spingerebbe qualunque essere umano a ritenere l’azione fattibile e perseguibile. Nel contesto che stiamo trattando può essere pensata come la ragionevolezza alla base dell’atto di costruzione della
pace tra gli stati, che si declina nel riconoscimento dei Diritti dell’uomo, atto che non richiede nulla se non l’umana facoltà di ragionamento.
Se quindi la giustificazione ha una portata collettiva, quando parliamo di motivazione ci spostiamo nella sfera dell’individuo. Un’azione collettiva volta al bene di
tutti è giustificata dalla sua stessa ragionevolezza, ma questo non implica che tutti lo facciano: è proprio la motivazione a spingere il singolo individuo ad agire per il bene collettivo. La motivazione sarà quindi distinta dalla giustificazione sia per la capacità che ha di indurre l’individuo ad agire per il collettivo, sia per il fatto che questa non sarà estendibile se non a gruppi che condividano culturalmente e ideologicamente la motivazione stessa. Un esempio è la fede che i cristiani hanno nella divinità di Gesù Cristo: per il credente, la fede nella divinità di Gesù e nella sua natura non solo umana, oltre che essere dono, è motivazione per agire secondo il suo insegnamento, in parte corrispondente ai Diritti umani. Questo però non è motivante allo stesso modo per qualcuno che in questo dato fondamentale della rivelazione non crede. Per questa ragione, costruendo la pace, è necessario che gli stati e l’unione di essi mettano il singolo nelle condizioni di scegliere di adeguarsi all’azione collettiva ragionevolmente giustificata, ma liberamente motivata nel rispetto della sua libertà di scelta.
Per concludere, riconosco che nel cammino della pace, pieno di nodi e di difficoltà, di porte strette attraverso le quali passare, rimaniamo una sola, fragile famiglia umana. Divisi per come siamo dalle strutture che nei secoli si sono stratificate nel nostro sentire culturale, è difficile fare fronte comune per costruire la pace. Il sogno però rimane vivo e, come un faro che guida nella notte, ci permette di camminare sicuri, fiduciosi della nostra umanità ma ancora di più convinti e certi che essa e i suoi limiti non sono l’ultima parola.
- I. kant, Per la pace perpetua, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 2018; per questo articolo ci si è rifatti anche alla prefazione all’edizione indicata scritta da S. Veca.
- L. F loRidi , La quarta rivoluzione, Raffaello Cortina Editore, Milano 2017.
- Carcere ideale progettato alla fine del XVII secolo dal filosofo J. Bentham. Il carcere prevedeva una struttura circolare che permettesse a un solo sorvegliante di controllare tutti i detenuti, da qui il nome: ciò che permette di vedere (“opticon”), tutti (“pan”)
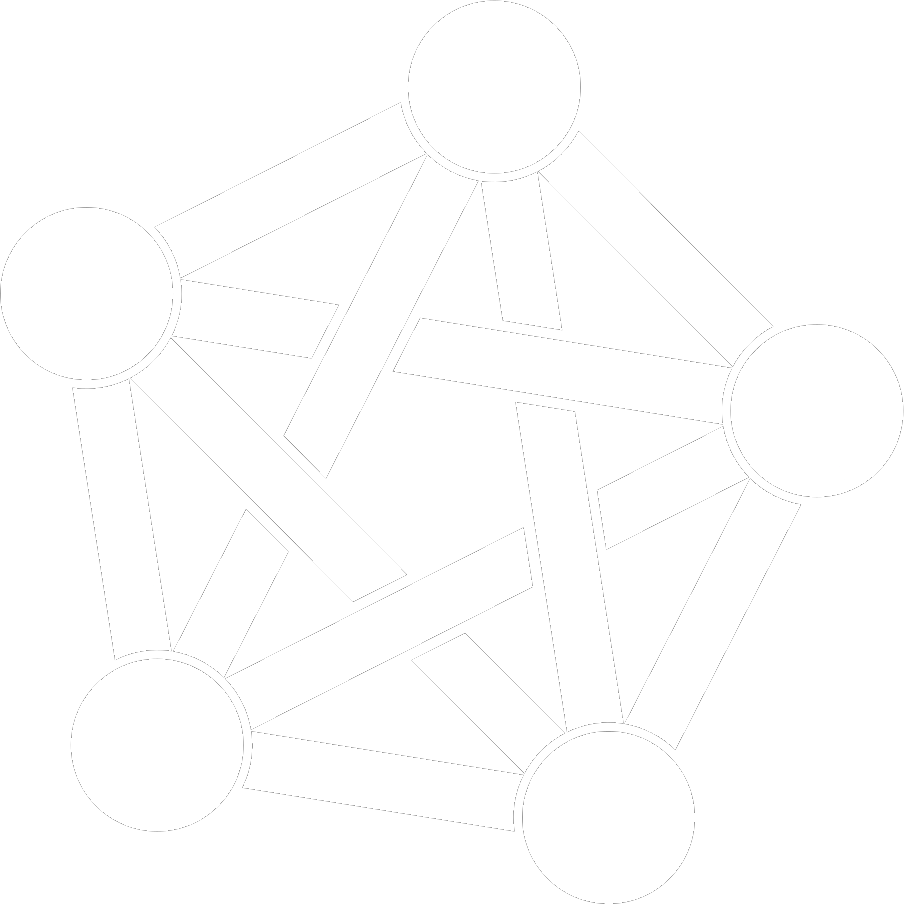
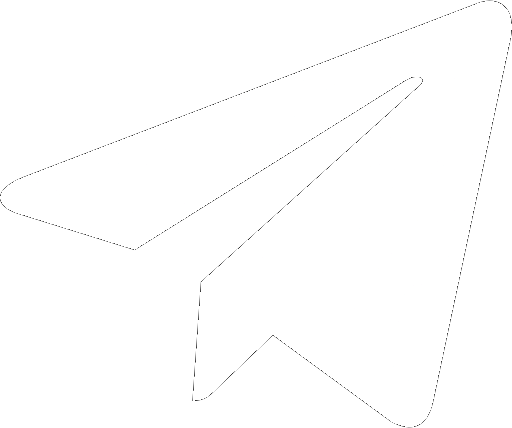







Scrivi un commento