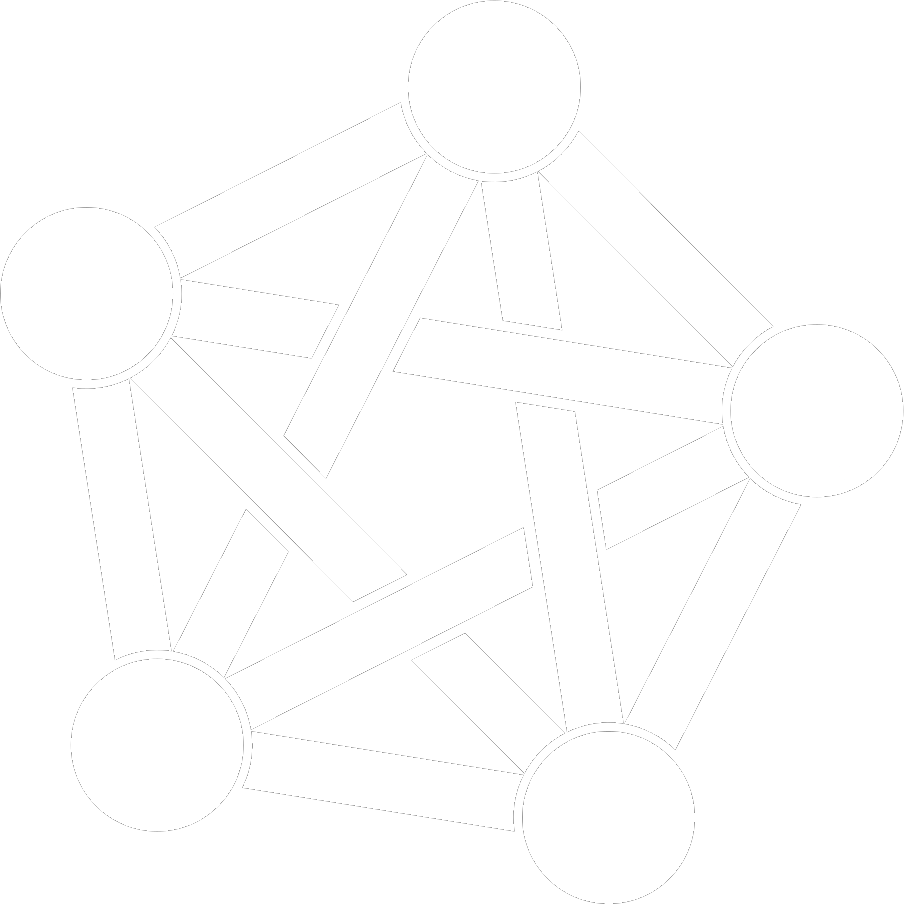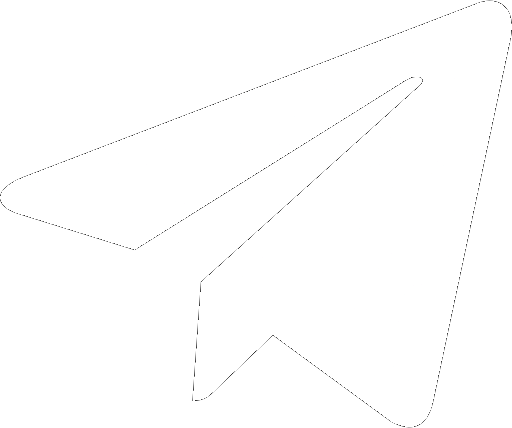di Filippo Pizzolato *
Un argomento ricorrente in questo delicato passaggio referendario, ma più in generale quando si parla di riforme costituzionali, è la suddivisione della Costituzione in due parti, di cui solo la seconda sarebbe pacificamente rivedibile. Tale impostazione è largamente proposta nella dialettica politica o nella divulgazione, ma con non pochi sconfinamenti nel dibattito scientifico. Si tratta però di un argomento davvero troppo leggero e pure non innocuo, perché, in fondo, invita a relativizzare l’importanza dei cambiamenti proposti, dato che questi non inciderebbero sulla prima parte della nostra Costituzione, cui volentieri non si fa mancare un tributo, magari solo retorico, di apprezzamento. Ciò nondimeno, se  si risale al paradigma di Costituzione prescelto dai costituenti, questo frequente approccio merita di essere sottoposto a critica. Se, infatti, prima e seconda parte sono oggettivamente divise sul piano topografico della struttura redazionale della Carta, ciò non significa evidentemente che tra le due non intercorrano collegamenti logici e assiologici e che i principi (che nella schematizzazione vengono abusivamente assorbiti nella parte dei diritti) non offrano imprescindibili criteri di decodificazione dei collegamenti stessi. Del resto, a conferma dell’inconsistenza della rigida demarcazione, la riforma tocca l’art. 48 della Costituzione, collocato nella prima parte.
si risale al paradigma di Costituzione prescelto dai costituenti, questo frequente approccio merita di essere sottoposto a critica. Se, infatti, prima e seconda parte sono oggettivamente divise sul piano topografico della struttura redazionale della Carta, ciò non significa evidentemente che tra le due non intercorrano collegamenti logici e assiologici e che i principi (che nella schematizzazione vengono abusivamente assorbiti nella parte dei diritti) non offrano imprescindibili criteri di decodificazione dei collegamenti stessi. Del resto, a conferma dell’inconsistenza della rigida demarcazione, la riforma tocca l’art. 48 della Costituzione, collocato nella prima parte.
L’utilizzazione ricorrente di questa semplicistica suddivisione può celare, consapevolmente o meno, la riproposizione di un risalente paradigma costituzionale, di tipo liberale, incentrato su un criterio di separazione stagna tra lo spazio delle libertà, appartenenti alla sfera privata degli individui, e quello delle istituzioni, appannaggio del potere pubblico, ancorché civilizzato dal costituzionalismo. Il complessivo dispositivo concettuale dello Stato moderno si regge infatti, a partire dalla teorizzazione di T. Hobbes, su un principio di separazione tra Stato e società, tale per cui, anche a seguito del lento processo di democratizzazione, l’unico punto di contatto tra lo Stato e la realtà sociale sottostante si realizza, come ha acutamente notato Giorgio Berti, tramite la rappresentanza politica, ristretto però alla “società che conta”1. Insomma, la democrazia non metterebbe in discussione la struttura portante dello Stato moderno, fondato, secondo questo tradizionale paradigma, su un’autorizzazione a governare a favore del sovrano, ma si limiterebbe a introdurre un meccanismo elettivo per tale investitura. Il diritto di voto diventa pertanto il principale, e quasi esclusivo, collante tra i due “ambienti”, pubblico e privato, e la cittadinanza si riduce al corpo elettorale. La contraddizione di questa concezione elettoralistica della cittadinanza si manifesta in capo ai minori, formalmente cittadini, eppur non elettori.
I nostri costituenti intesero segnare una netta discontinuità, il cui senso è bene sintetizzato già dalla formula inaugurale della Costituzione, non si trattava di una formula meramente retorica o vuota, ma di una precisa aspirazione a una democratizzazione sostanziale, in polemica con la democrazia solo formale propria dello Stato liberale.
Proprio rispetto a questo classico dispositivo concettuale statuale, i nostri costituenti – e in particolare quelli di ispirazione cattolica – intesero segnare una netta discontinuità, il cui senso è bene sintetizzato già dalla formula inaugurale della Costituzione, con cui si fonda la repubblica democratica sul lavoro. Come risulta chiaro dai dibattiti costituenti, non si trattava di una formula meramente retorica o vuota, ma di una precisa aspirazione a una democratizzazione sostanziale, in polemica con la democrazia solo formale propria dello Stato liberale. Con l’idea di democratizzazione sostanziale non si alludeva agli esperimenti, allora ancora in corso, di organizzazione comunista della società, bensì alla promozione della partecipazione effettiva dei cittadini. Si voleva cioè estendere tale partecipazione sia in termini spaziali, in modo che essa investisse anche le sfere dei rapporti sociali ed economici; sia in termini temporali, perché si “ferializzasse” per il tramite dell’esercizio quotidiano della costruzione cooperativa della società. In questo quadro costituzionale, tutte le libertà sono implicate e valorizzate dalla democrazia, non solamente il diritto di voto, perché tutte, se accoppiate alla responsabilità e alla solidarietà (come vuole l’art. 2 Cost.), aprono ai cittadini (anche ai minorenni!) possibilità di partecipazione alla cura della convivenza. Dunque le libertà e le connesse responsabilità, di cui il lavoro è il significativo archetipo, sono strumenti di costruzione dal “basso” dell’ordine sociale e del bene comune. E, al contempo, sono fattori di costruzione delle istituzioni, come bene messo in luce da uno dei più autorevoli commenti sistematici all’art. 2 della Costituzione2. Il ripescaggio, da un lungo oblio, del principio di sussidiarietà, nelle sue declinazioni orizzontale e verticale, ha consentito, ma solo in parte e non senza ambigue traduzioni, la riscoperta della portata complessiva di questo disegno costituzionale che affidava la cura del bene comune alla partecipazione feriale dei cittadini, nutrita di diritti e doveri, e al “potere istituente” della società civile3.
Dovrebbe ora essere chiaro perché la pretesa disarticolazione tra prima e seconda parte della Costituzione è semplicemente un “non senso”. Le forme, anche organizzative e istituzionali, della democrazia sono infatti intimamente connesse con l’apertura alla dimensione partecipativa e cooperativa delle libertà dei cittadini. E, allo stesso modo, dovrebbe essere più chiaro perché il modo in cui un processo riformatore affronta il nodo delle autonomie politiche territoriali non possa essere un tema marginale o indifferente ai principi e perfino alle libertà costituzionali. L’art. 5 Cost. offre sul punto una cerniera di senso tra ambito della libertà e costruzione istituzionale della Repubblica. Utilissima e illuminante è, a riguardo, la risalente, ma attualissima, riflessione di Giorgio Berti: “al fondo dell’idea di autonomia vi è sempre un principio di autogoverno sociale ed ha senso introdurre una autonomia sul piano istituzionale in quanto sia sicuro che essa serve a vivificare la partecipazione sociale”4.
Le libertà e le connesse responsabilità, di cui il lavoro è il significativo archetipo, sono strumenti di costruzione dal “basso” dell’ordine sociale e del bene comune. E, al contempo, sono fattori di costruzione delle istituzioni.
Le libertà e le connesse responsabilità, di cui il lavoro è il significativo archetipo, sono strumenti di costruzione
dal “basso” dell’ordine sociale e del bene comune. E, al contempo, sono fattori di costruzione delle istituzioni.
Se dunque si può discutere e sostenere che le Province e magari anche le Regioni non abbiano fornito una buona prova nel compito loro affidato di dare veste e veicolo alla partecipazione civica, occorrerebbe porsi il problema della riforma di questi enti territoriali, anziché procedere sic et simpliciter a una loro soppressione o sostanziale esautorazione. Questa considerazione conduce ad avanzare qualche ulteriore perplessità sull’approccio seguito dalla riforma costituzionale approvata, che non si cimenta neppure nel compito, certo più impegnativo, del “ri-radicamento” delle Regioni entro il tessuto sociale di riferimento, ma si limita a svuotarne le attribuzioni, soprattutto per il tramite di una generica e per questo minacciosa clausola dell’interesse nazionale.
Da quanto precede può sorgere la legittima domanda se la riforma, anziché muoversi nel solco dei principi costituzionali, non comporti, surrettiziamente, ma non inconsapevolmente, un mutamento di paradigma. Esso è talora dichiarato, anche se, prudentemente, non è posto in esplicita contraddizione con il fondamento lavoristico della Costituzione repubblicana. Si avanza infatti un’idea, in sé legittima, di democrazia di investitura, di ispirazione schumpeteriana, che è messa in contrapposizione polemica con la declinazione, che potremmo definire kelseniana, della democrazia della mediazione parlamentare5. Non si vuole sostenere la tesi che l’un modello sia democratico e l’altro no o, peggio ancora, che non lo siano né l’uno né l’altro. Si vuole piuttosto sottolineare che i principi costituzionali iscrivano la nostra Repubblica entro un orizzonte diverso tanto da una democrazia ridotta a investitura di leadership governanti, alla Schumpeter; quanto, per la verità, rispetto a una democrazia, come quella kelseniana, che, pur aperta a processi mediativi, li immagini tutti interni alla sfera istituzionale. Detto per inciso, questa idea di democrazia, orientata alla selezione di élites governanti, segna il punto di saldatura tra la riforma della Costituzione e il ridisegno (realizzato con l’Italicum) della legge elettorale, ciò che rende difficilmente sostenibile la sconnessione delle due questioni (e delle due battaglie). L’imperativo di avere un Governo “la sera stessa delle elezioni” si accompagna, non senza coerenza, a una ristabilita subalternità delle autonomie politiche territoriali rispetto all’indirizzo politico del Governo centrale6, rafforzato da una sicura maggioranza alla Camera dei Deputati (l’unica che intrattenga il rapporto di fiducia con il Governo stesso). Il Senato delle autonomie, per com’è stato abbozzato, non sembra offrire rassicurazioni credibili circa una compensazione, a vantaggio delle Regioni, dell’autonomia persa sul territorio, che, secondo talune prospettazioni, sarebbe parzialmente recuperata tramite la partecipazione a procedimenti decisionali dello Stato centrale.
Sarebbe prova di serietà interrogarsi sull’incerta compatibilità di questa evoluzione con il quadro dei principi costituzionali. Se è vero che non si deve trasformare quel quadro in una camicia di Nesso, pare però che la questione di coerenza, per lo più, non sia nemmeno abbozzata, nel contesto di un diffuso quadro interpretativo che tende, ma non da oggi (e nemmeno da ieri), a depotenziare la carica innovativa e finanche rivoluzionaria dei principi stessi della Costituzione. Essi ormai vengono confusi con la tradizionale, per quanto nobile, impostazione garantistica liberale. E la formula “fondata sul lavoro” resta come un curioso orpello decorativo o, in molti inconfessabili (o confessati) pensieri, come un pericoloso cimelio bellico da isolare e disinnescare.
Insomma, e in conclusione, se si guarda al paradigma entro cui i costituenti hanno storicamente pensato la nostra Costituzione, non si può fare a meno di rilevare una distanza tra la riforma sottoposta a referendum e la democrazia sostanziale cui essi aspiravano. È vero che questa distanza non si produce ora per la prima volta, ma è, in qualche modo, il nodo veramente strutturale dell’inattuazione costituzionale. Solo che stavolta – rispetto al fondamento lavoristico della democrazia, ma anche rispetto alla pur tanto criticata riforma del titolo V del 2001 – s’imbocca una direzione opposta.
*Docente di Dottrina dello Stato
all’Università Cattolica di Milano
e Diritto Pubblico all’Università
degli studi di Milano-Bicocca
NOTE
- G. Berti, Art. 5, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 279.
- A. Barbera, sub art.2, in Commentario alla Costituzione, cit., p. 59 ss..
- Secondo la bella espressione di M. Magatti, Il potere istituente della società civile, Laterza, Roma-Bari 2005.
- G. Berti, Art. 5, cit., p. 288. Cfr. F. Benvenuti, Le autonomie locali (1969), ora in Id., Scritti giuridici. III. Articoli e altri scritti (1960/1969), Vita e Pensiero, Milano 2006, p. 2719.
- Per la differenza dei due modelli, A. Mastropaolo, Crisi dei partiti o decadimento della democrazia?, in Costituzionalismo.it, 1/2005.
- Molto bene su questo punto S. Aru, La clausola di supremazia statale nel ddl di revisione costituzionale: si scrive “interesse nazionale”, si legge “indirizzo politico-governativo”, in Costituzionalismo.it, 1/2016.