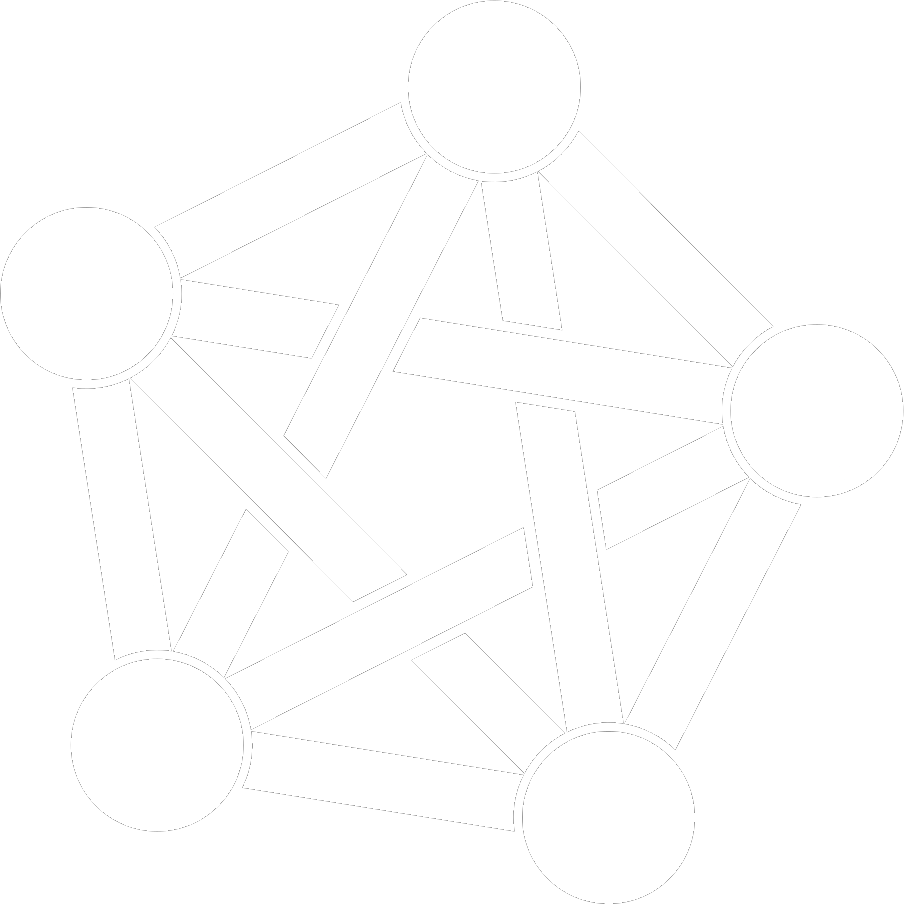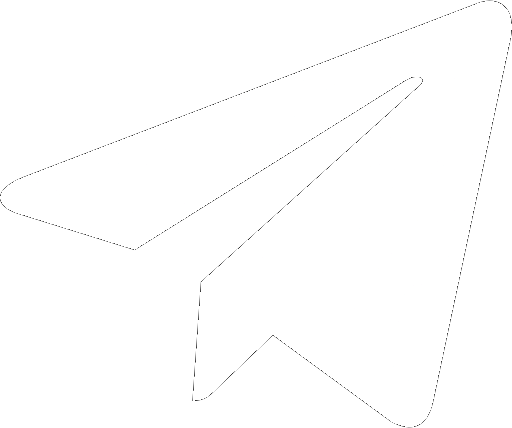di Jihad Youssef *
 Un giorno, a Damasco, sono entrato con due amici da un loro conoscente, non ricordo come sono finito a parlare dei presunti miracoli che i musulmani affermano siano successi presso di loro e grazie ai loro «santi». Parlavo a voce bassa per paura che mi sentissero i vicini musulmani. Prendevo in giro le pretese e le credenze dei nostri «fratelli e sorelle musulmani». Nonostante ciò, quando uno dei tre mi chiese se fossero veramente nostri «fratelli», gli risposi: «Sì, nonostante tutto siamo fratelli». Avevo 16 anni. Il giorno dopo ho scoperto che la persona che ci ospitava era musulmano. Mi sono arrabbiato con i due amici ma più che altro mi sono vergognato di me stesso. Da quel giorno non ho più preso in giro nessuno.
Un giorno, a Damasco, sono entrato con due amici da un loro conoscente, non ricordo come sono finito a parlare dei presunti miracoli che i musulmani affermano siano successi presso di loro e grazie ai loro «santi». Parlavo a voce bassa per paura che mi sentissero i vicini musulmani. Prendevo in giro le pretese e le credenze dei nostri «fratelli e sorelle musulmani». Nonostante ciò, quando uno dei tre mi chiese se fossero veramente nostri «fratelli», gli risposi: «Sì, nonostante tutto siamo fratelli». Avevo 16 anni. Il giorno dopo ho scoperto che la persona che ci ospitava era musulmano. Mi sono arrabbiato con i due amici ma più che altro mi sono vergognato di me stesso. Da quel giorno non ho più preso in giro nessuno.
In Siria, fino a tre anni fa, eravamo fieri davanti al mondo, e tra i siriani stessi, dell’esemplare convivenza tra musulmani e cristiani. Tuttavia, di nascosto ci parlavamo male l’uno dell’altro. Ogni gruppo, nelle rispettive case, famiglie e ambienti, si considerava migliore dell’altro e insegnava ai suoi bambini che gli «altri» sono falsi e che «noi» i giusti, mentre quando c’incontravamo tutto era «burro e miele». Ora vivo in un paese divorato dalla guerra, dalla paura e dall’odio, innanzitutto, tra gli stessi musulmani, sunniti e sciiti, da una parte, e tra musulmani e cristiani, dall’altra. Adesso si parla male dell’altro apertamente, non più in segreto.
Noi, nella nostra comunità monastica di Deir Mar Musa, abbiamo scelto non solo di non parlare male dei nostri fratelli musulmani, ma d’imparare a parlarne bene, ad apprezzare quello che vivono, quello che credono. Abbiamo deciso di conoscerli meglio e riconoscere il bene che hanno e considerarlo anche nostro. Perciò quando ne parliamo lo facciamo come se ci fossero sempre musulmani presenti: non solo per non fare brutta figura, ma perché ormai fanno parte dell’orizzonte della nostra vita. Non si può più escludere l’altro, non si deve più considerarlo pericoloso e minacciante, bisogna, invece, creargli uno spazio permanente nella propria esistenza. Così se c’è qualcosa di negativo da dire, lo si può fare serenamente e non a voce bassa perché l’intento non è quello di parlare male dell’altro, cattivo e brutto, ma quello di costruire insieme un futuro più umano e più onesto. Le differenze sono da apprezzare, da valorizzare e da sfruttare per maggior bene e per contribuire concretamente a costruire una pace duratura. Dialogare con l’altro vuol dire, innanzitutto, rispettare la sua alterità: religiosa, culturale, etnica e così via. Vuol dire riconoscere la sua dignità uguale alla tua, anche se ci fossero differenze profonde a livello di civilizzazione e di comprensione delle cose più ovvie ed essenziali di qualsiasi natura. Solo così possiamo sognare di costruire la pace. La mancanza di guerra, la serenità basata sulla sicurezza che viene dalla forza della legge o dello stato, la tranquillità che risulta dagli accordi politici ed economici basati sugli interessi, non sono ancora la vera pace. Alcune cose sono necessarie ma non fanno la pace tous court . Non c’è pace senza perdono e senza una propria ascesi: senza riconoscere i propri limiti, senza abnegazione. Cominciamo a essere operatori di pace quando auguriamo a e desideriamo per gli altri quello che auguriamo per noi stessi, quando riconosciamo loro diritto quello che consideriamo nostro.
Nella politica di oggigiorno, la parola “pace” è stata massacrata, sfigurata e mal utilizzata, come un asciugamano in un bagno pubblico. È una parola usata male a tutti i livelli, è una bandiera tirata fuori da chiunque ma senza rappresentare necessariamente coloro che la tengono in mano. È stata troppo predicata e usata fino a svuotarla dal suo contenuto, è diventata un giocattolo. Con la scusa di combattere il terrorismo si lavora costantemente contro la pace, basta vedere le enormi cifre di denaro che si dedicano all’armamento, soprattutto dai Paesi che predicano la pace e i diritti dell’uomo. Ci sono ancora Paesi del primo mondo che sfruttano altri Paesi e li tengono sotto il giogo della nuova schiavitù del colonialismo economico. Ci sono ditte internazionali che, per assicurare il lusso e la comodità di una parte delle loro società, sfruttano, ancora oggi, bambini, donne e uomini mal pagati che lavorano in condizioni disumane, in circostanze nocive alla loro salute e alla loro dignità. Di quale pace si tratta oggi? Di che tipo di pace abbiamo bisogno? Bisogna svegliarsi dalle illusioni in cui viviamo, dalla comodità che soffoca in noi la solidarietà e la sussidiarietà con il povero e l’emarginato. Scrivo queste righe alla vigilia dell’incontro di “Ginevra 2” che dovrebbe cercare la via o le vie d’uscita dal problema siriano: nel frattempo giungono le notizie della guerra nel Sud Sudan, questa volta tra cristiani, per non parlare di altri posti come l’Iraq, il Libano e via dicendo. Che cosa possiamo fare noi, persone “normali” e semplici? Come monaci e monache abbiamo cercato per trent’anni di costruire la pace lavorando con la società locale sull’ambiente, sul turismo che rispetta la natura, abbiamo cercato di andare i luoghi in cui non si andava, di aprire le porte che si dovevano tenere chiuse, abbiamo provato a studiare la religione musulmana non per confutare i musulmani nelle discussioni apologetiche ma per illuminare la nostra ignoranza su quella fede che altri vivono da circa 1400 anni. Abbiamo voluto trasformare il nostro monastero in un’oasi nel deserto dove si possono incontrare Dio e i fratelli, cristiani e non. Abbiamo cercato di mettere a disposizione dei giovani uno spazio libero e largo, dove essi possono incontrarsi con l’originalità della fede e con l’essenzialità della vita spirituale in un orizzonte universale in cui convergono i loro diversi orizzonti particolari. Vogliamo amare i musulmani non con parole e teorie, ma concretamente. Amarli con lo stesso amore che Gesù ha per loro, un amore particolare perché ogni persona è particolare agli occhi di Dio. L’Islam fa, ormai, parte costante della nostra preghiera e vita spirituale, sta sempre all’orizzonte di ogni nostra celebrazione e culto.
Con questo, certamente non pretendiamo di aver risolto il problema nemmeno nel nostro piccolo, anzi le difficoltà in cui ci siamo imbattuti sono tante a cominciare dal rifiuto dei nostri stessi fratelli in Cristo a questa idea e a questa missione. Abbiamo incontrato pregiudizi e ostacoli sia da musulmani sia da cristiani. Anche il cammino stesso è stato difficile, perché minato dalla paura e dall’ignoranza, dall’odio e dal desiderio di vendetta, dal sentimento di essere vittime dell’altro. Se però guardiamo a questi anni troviamo che ci sono amicizie sorte e fortificate con il tempo: alle volte basta incontrarsi per fare una cosa buona e giusta, lo sguardo che avevamo di loro e che avevano di noi è cambiato. Ricordiamo che nonostante tutto siamo fratelli.
* Monaco di Deir Mar Musa, Monastero di San Mosè l’Etiope