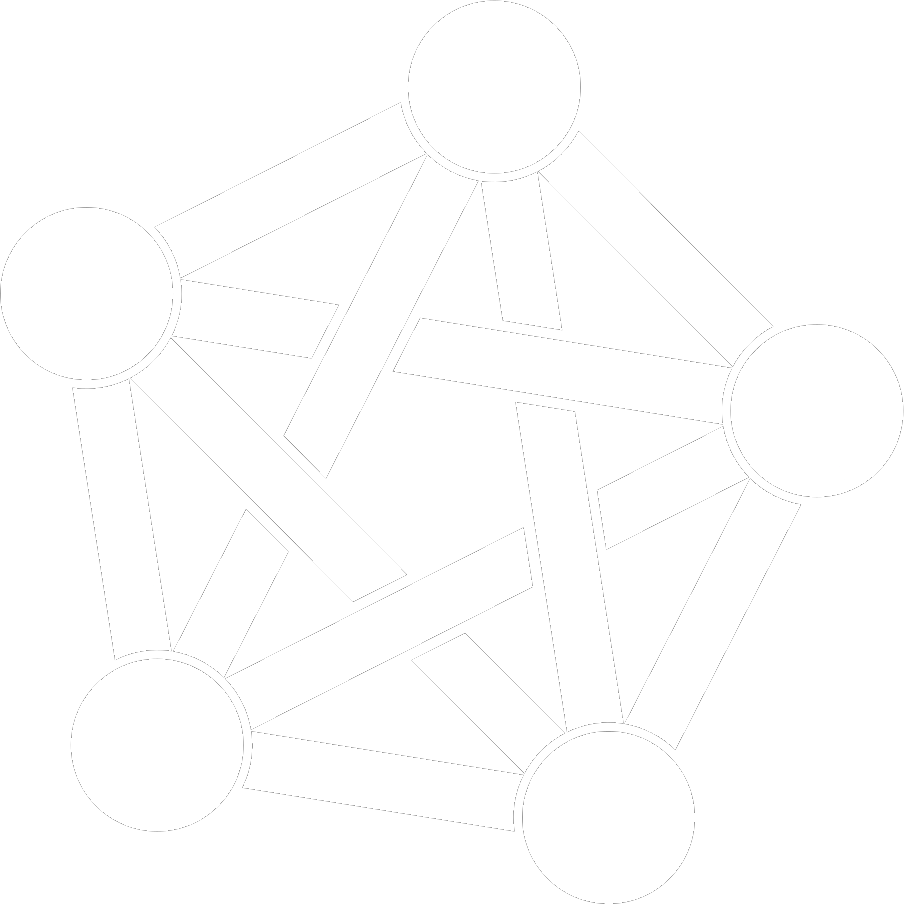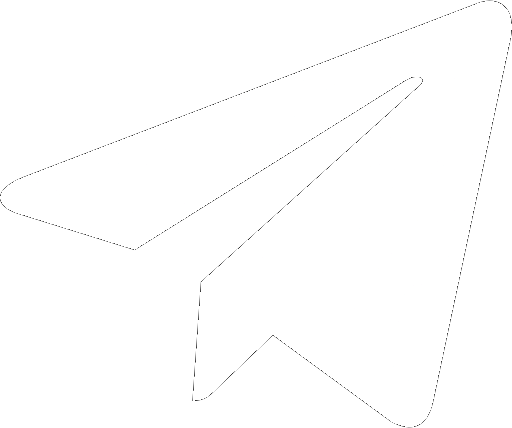di Francesca Simeoni *
Non domandarci
«Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,/ sì qualche storta sillaba e secca come un ramo./ Codesto solo oggi possiamo dirti,/ ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.»[1] La poesia, fedele narratrice dello spirito del proprio tempo, in questi versi di Eugenio Montale del 1923 mostra l’afasia cui è costretta di fronte alle grandi questioni. Non si chieda più ai poeti la soluzione e la chiave del senso, dopo secoli di versi altisonanti e carichi di magniloquente umanità, da Dante al dissacrante Baudelaire. Paralisi della risposta, ma al tempo stesso paralisi del domandare: “non chiederci la parola”. Il Novecento è percorso nettamente dalla consapevolezza del crollo di ogni risposta sicura al destino dell’uomo, alla vicenda che è lo “stare al mondo”. La postmodernità può essere descritta a buon titolo come epoca del disincanto e del dubbio radicale, dubbio che giunge ad intaccare la possibilità stessa di un senso rintracciabile del reale.
 Negli stessi anni in cui Montale compone i suoi Ossi di seppia, immagine emblematica della riduzione dei frammenti di senso a salmastri relitti, a rottami, Martin Heidegger fa invece emergere con vibrante imponenza sulla scena del pensiero occidentale la questione dell’essere. Nel 1927 viene dato alle stampe Essere e tempo, dove il filosofo ridesta l’interrogativo fondamentale sopito e obliato dall’uomo tecnologico: cur est aliquid? Domanda antica che accompagna l’uomo di tutti i tempi, poiché l’uomo stesso è quell’ente tra tutti gli enti che, solo, si pone questa domanda: perché vi è qualcosa? L’uomo è questa domanda, strano gioco dell’evoluzione che ha prodotto il proprio dubbio.
Negli stessi anni in cui Montale compone i suoi Ossi di seppia, immagine emblematica della riduzione dei frammenti di senso a salmastri relitti, a rottami, Martin Heidegger fa invece emergere con vibrante imponenza sulla scena del pensiero occidentale la questione dell’essere. Nel 1927 viene dato alle stampe Essere e tempo, dove il filosofo ridesta l’interrogativo fondamentale sopito e obliato dall’uomo tecnologico: cur est aliquid? Domanda antica che accompagna l’uomo di tutti i tempi, poiché l’uomo stesso è quell’ente tra tutti gli enti che, solo, si pone questa domanda: perché vi è qualcosa? L’uomo è questa domanda, strano gioco dell’evoluzione che ha prodotto il proprio dubbio.
Domanda antica
Accanto a ciò che gli è dato, accanto a quanto conosce, sperimenta e compie, l’uomo ne cerca dunque il senso. Da un lato perché “ha senso” della propria vita, cioè ne ha sensibilità e ricettività, la comprende e ne sente lo scorrere, ne percepisce le potenzialità e ne ha intelligenza. Dall’altro lato perché ha bisogno di un senso per la propria esistenza, ossia di un significato e di una direzione, di salvaguardarla dal caso, ossia dal non senso, o dal male, ossia da un senso deleterio.
È straordinario che questa percezione così inquieta e vibrante dell’esistenza che si esprime nel domandare postmoderno trovi posto anche nel dialogo tra uomo e Dio raccontato nella Bibbia e nella tradizione giudaico-cristiana. L’uomo contemporaneo può trovare in Qoelet la sua stessa spietata e scettica ricerca di senso.
Il testo appartiene alla letteratura biblica sapienziale, che a differenza della Torah e dei Profeti non mette al centro il popolo di Israele e la sua relazione diacronica con Dio, bensì accoglie, come in Giobbe, Siracide e Sapienza, le riflessioni dell’individuo, focalizzando la prospettiva sulla vicenda di un singolo. La datazione del libro sembra attestarsi attorno al III sec. a.C. e la collocazione geografica più accreditata sarebbe la Palestina, in particolare la città di Gerusalemme, nella fase della dominazione greca[2]. Il genere letterario sapienziale ha rimandi e paralleli nella letteratura di tutta l’area egiziana e mesopotamica e qualcuno ha voluto scorgere nelle riflessioni dell’autore l’influsso del pensiero delle scuole ellenistiche, dello scetticismo e dell’epicureismo. Tuttavia Qoelet mantiene la sua originalità e il suo radicamento nella tradizione, tutta peculiare, ebraica[3].
Una risposta dolorosa
L’autore, che si nasconde sotto lo pseudonimo di Qoelet[4], nei primi versetti viene identificato con Salomone, tradizionale figura veterotestamentaria del re saggio, capace di ascoltare e di discernere bene e male[5]. Nel suo incessante interrogare ed «esplorare con sapienza tutto ciò che si compie sotto il cielo» (Qo 1, 13), Qoelet «si ispira a questa disposizione all’ascolto», commenta Erri De Luca nella sua rilettura, «e scrive il libro di chi ha avuto in dono una risposta dolorosa»[6].
Si dipana così in 12 capitoletti il vaglio critico di Qoelet, e i punti interrogativi si susseguono a ritmo regolare nell’incalzante ricerca, riproponendo a piè sospinto il martellante quesito «cosa guadagna l’uomo in tutte le fatiche in cui si affatica sotto il sole?» (Qo 1, 3), quale vantaggio gli viene dall’affanno cui si sottopone dandosi da fare nella vita che conduce sotto il cielo? Egli passa in disamina ogni aspetto dell’esistenza, dagli elementi cosmologici e naturali (Qo 1, 4-7), a quelli antropologici e sociali (Qo 1, 12 – 4, 16 e 5, 7 – 6, 10): il lavoro, le azioni, la conoscenza, le ricchezze, le grandi opere. Unico limite di indagine è quello tracciato dall’arco del sole, che nel suo sorgere e tramontare scandisce il tempo e la sua ripetitività, decreta il passare di ogni cosa, il suo inizio e la sua fine inesorabile. «C’è un tempo per ogni cosa»[7], osserva Qoelet, ma ogni cosa posta nel tempo è da esso livellata. Il tempo infatti porta con sé il limite e costringe l’uomo a misurarsi con la propria finitezza, per usare un termine che richiede uno sbalzo di 2000 anni di riflessione e riconduce ad Heidegger. La morte infatti, grande punto interrogativo infinitamente incolmabile, rimane il luogo e il tempo della nostra vita di cui non possiamo disporre. La domanda di senso nasce proprio da questo termine-fallimento dove la vita si estingue. Essa è il termine sorgivo del sogno e dell’utopia umana, del desiderio di felicità. La percezione della nostra mortalità, di un possibile ma già reale terminare di questo presente, ci costringe a domandare.
Per Qoelet tuttavia non solo il senso delle cose che l’uomo compie e per cui si preoccupa è cancellato dal loro essere effimere, ma la contraddizione anche le investe, le corrode e riduce lo sforzo umano a inutilità. Certamente, riconosce il saggio, la sapienza è preferibile alla stoltezza e la giustizia all’empietà: vi è dunque una gerarchia di valori di senso, che ne rende gli uni preferibili agli altri. Eppure «una stessa sorte tocca a tutti» ( Qo 2, 14), all’empio come al giusto, allo stolto come al saggio. Anzi, il più delle volte predominano i secondi sui primi e hanno destino migliore.
Hebel habalim
«Vanità di vanità, tutto è vanità»: è questa infine la sanzione, frutto di fatica e di incessante richiesta, che apre e chiude i 12 capitoli dell’Ecclesiaste. Questa è la sapienza di Qoelet, sapienza che produce dolore, sapienza laica di quanto avviene sotto il sole, il cui senso rimane «lontano e profondo profondo»[8], inaccessibile al verbo “trovare”. Tutto è habel habalîm, nel testo ebraico, ossia “soffio, brezza, vento, vapore”, vocabolo che nel lessico biblico indica l’ambito semantico dell’effimero, viene usato dal salmista per indicare la condizione biologica transeunte dell’adam: “l’uomo è come un soffio (hebel), i suoi giorni come ombra che passa” (Sal 144, 4). Nel testo greco l’espressione diventa mataiotes mataioteton: il senso che il saggio trova a quanto accade sotto il sole è “vuotezza, vacuità, inconsistenza”, vocabolo che Platone usa nel Sofista per indicare la falsa conoscenza prodotta dall’opinione, in opposizione alla vera scienza[9]. E così nella Vulgata il senso di Qoelet diventa vanitas, un vuoto che si trasforma in “caducità” e si contrassegna per un’incrinatura semantica moraleggiante. In ambito cristiano quest’espressione andrà a confermare la distanza da Dio cui è sottoposta la condizione creaturale, destinata alla vacuità.[10]
Alla domanda di senso dunque Qoelet non risparmia una risposta spietata e disincantata, eppure il testo ebraico si mantiene su una visione dell’esistenza non così nichilistica. Le riflessioni di Qoelet infatti sono limitate a “quanto accade sotto il sole”, nel raggio di esperienza dell’uomo che abita la terra. Dio, che sta in cielo (Qo 5, 1), sembra escluso dal susseguirsi delle vicende livellate dal tempo e dal sole. Qoelet ritrova il senso dell’umano affaticarsi nella gioia che accompagna questa fatica. Egli invita a godere dei brevi giorni concessi sulla terra e ricorda come la gioia sia dono di Elohim (Qo 3, 11). Vi è infatti qualcosa che strappa l’uomo al destino di “soffio” cui tutto è sottoposto sotto il sole, poiché «Dio ha messo nel suo cuore l’eternità» (Qo 3, 11), che appartiene a quanto sta in cielo. Al centro del libro di Qoelet vi è dunque una fuoriuscita, l’irrompere di un principio diverso da quello che il saggio riconosce in tutte le cose. Esse sono hebel, sottoposte alla legge del tempo che le nullifica e le svuota di senso, eppure l’uomo ha nel cuore l’eternità, qualcosa di diverso, che lo chiama a gioire nella fatica cui la terra lo costringe, a goderne perché essa è dono di Elohim.
Nei suoi esiti Qoelet si fa prossimo alla sensibilità disincantata del nostro tempo: non vi è risposta certa alla domanda di senso poiché «l’uomo non ha potere sul vento, così da trattenerlo» (Qo 3, 11), non può disporre completamente di quanto compie e costruisce, se non in termini negativi, come riconoscono i versi di Montale: «ciò che non siamo, ciò che non vogliamo».
L’unica voce che manchi all’inventario
E dunque la ricchezza non sta nella risposta, pur sempre cercata, bensì nel domandare, mai sopito: neppure nel postmoderno fallimento di ogni ideologia rimane tacitato il cur est aliquid? È questo domandare che rivela il cielo in noi, che stiamo sotto il sole. Rivela l’ulteriorità che pur sempre costituisce quel soffio che è l’uomo, meraviglia di Qoelet. Nell’epoca del dominio virtuale ed economico dell’esistenza, epoca della possibilità realizzata di conoscere tutto, in cui tutto è dato o ottenibile, utile o utilizzabile, sensato se profittevole, al di là del conteggio del dare-avere vi è qualcosa che resiste a questo livellamento di senso. «La protesta contro di esso/ noi la chiamiamo anima./ E questa è l’unica voce/ che manchi all’inventario»[11]: è ancora la poesia, nei versi di Wislava Szymborska, a trovare lo spazio per quest’ulteriorità, per una protesta che raccoglie l’interrogativo di senso. La stessa poetessa conclude scettica a proposito: «da dove venga ancora questo spazio in me/ – non lo so»[12]. Però di certo quello spazio sfugge, ancora, alla vanità del tutto.
* già Presidente nazionale della FUCI
[1] E. Montale, Tutte le poesie, a cura di G. Zampa, Milano 2012, p. 29.
[2] Cfr. Qoèlet, traduzione e commento di J. Vilchez Lindez, Roma 1997, pp.
[3] Cfr. G. von Rad, Teologia dell’Antico Testamento, ed. italiana a cura di M. Bellincioni, I, Brescia 1972, p. 513.
[4] Lo pseudonimo ebraico Qohelet rimanda al vocabolo qahal, “assemblea”, in greco ekklesia: da qui il greco-latino Ecclesiastes, divenuto la titolatura comune e canonica nell’Occidente cristiano.
[5] Cfr. 1 Re 3, 9.
[6] Kohèlet / Ecclesiaste, traduzione dall’ebraico a cura di E. De Luca, Milano 2011.
[7] Qo 3.
[8] Qo 7, 24.
[9] Plat. Soph. 1c.
[10] Per una disamina approfondita del significato di hebel si veda l’Excursus II in Qoèlet, traduzione e commento di J. Vilchez Lindez cit., pp. 454-461.
[11] W. Szymborska, Nulla è in regalo!, da La fine e l’inizio: poesie; a cura di P. Marchesani, Milano 20003.
[12] Cfr. W. Szymborska, Grande numero, a cura di P. Marchesani, Milano 2006.