Per Fuci, Msac e Giovani di Ac la Valutazione di Impatto Generazionale è un’intuizione lungimirante, ma senza strumenti vincolanti rischia di restare un rito formale
di Francesco Lotito, Matteo Zappa e Emanuela Scarfò
Qualche settimana fa si è concluso l’iter parlamentare che ha condotto all’approvazione del cosiddetto “DDL Casellati”, un pacchetto di norme che, nell’ambito di una serie di interventi riguardanti la semplificazione e la qualità della legislazione, ha introdotto l’obbligo di correlare alle leggi di nuova emanazione una Valutazione di Impatto Generazionale (VIG), un report che consideri l’impatto sociale, politico ed economico sulle future generazioni delle misure comprese all’interno del singolo testo di legge appena approvato.
Facciamo un esempio. Se dalla VIG allegata a una qualsiasi misura di legge traspaiano potenziali impatti negativi sulle future generazioni, quel provvedimento si esporrebbe a particolari critiche, facendo sì che per scongiurare il rischio che ciò accada, le parti politiche provino a mantenere alta l’attenzione sul tema in sede della sua redazione: non converrebbe a nessuna forza politica di vedere certificata nero su bianco una propria mancanza di attenzione alla programmazione “sostenibile” e lungimirante. La cura delle generazioni più giovani può finalmente tornare centrale nella progettazione politica grazie a strumenti come la VIG.
C’è però una grande incognita, come spesso capita quando si tratta di interventi di legge presentati come rivoluzionari. In questo caso, il dubbio che sorge è: se la VIG allegata ad un testo normativo dimostrasse che i provvedimenti in esso contenuti hanno un impatto generazionale fortemente negativo a livello sociale, ambientale, economico, che cosa accadrebbe? Da ciò che traspare finora – in attesa dei decreti attuativi – la risposta è: nulla. Vero, quel provvedimento si esporrebbe a forti critiche, ma al momento non c’è niente che possa impedire che la legge venga ugualmente approvata e che le sue conseguenze negative si producano.
È necessario, quindi, uno sforzo ulteriore per evitare che un’ottima intuizione non raggiunga la vera finalità per la quale essa nasce, così evitando che l’attenzione alle nuove generazioni resti – ancora una volta – qualcosa che in superficie tutti riconoscono come importante, ma che nessuno riesce ad incarnare fino in fondo.
La sostenibilità come metodo politico
La Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) nasce come strumento ambizioso e necessario: un tentativo di rendere la politica più lungimirante, capace di valutare in anticipo le conseguenze economiche, ambientali e sociali delle leggi sulle generazioni future. In questo senso, si inserisce pienamente nel paradigma della sostenibilità integrale, che riconosce come lo sviluppo debba poggiare su tre pilastri inscindibili: quello economico, che garantisce la solidità e l’equità nella distribuzione delle risorse; quello ambientale, che custodisce il pianeta come bene comune; e quello sociale, che promuove coesione, partecipazione e giustizia.
Il valore della VIG sta nel tentativo di tradurre in pratica l’idea che la sostenibilità non è un principio astratto, ma una responsabilità concreta, sia intragenerazionale (tra i cittadini di oggi) che intergenerazionale (tra le generazioni di oggi e quelle di domani). Significa chiedersi, per ogni legge: stiamo costruendo un futuro sostenibile o stiamo spostando i costi sul futuro?
Tuttavia, proprio perché così ambiziosa, la VIG presenta anche sfide non trascurabili. Sul piano economico, richiede di andare oltre la logica del breve termine, di considerare benefici e costi futuri in modo realistico, evitando al tempo stesso di paralizzare le scelte pubbliche con analisi teoriche o eccessivamente burocratiche. Sul piano ambientale, promette di misurare l’impatto delle politiche sulla qualità del pianeta, ma rischia di restare debole se mancano dati solidi, criteri chiari e strumenti per trasformare la valutazione in decisione. E sul piano sociale, ponendosi l’obiettivo di garantire equità e partecipazione, la VIG presenta l’obiettivo di coinvolgere realmente i giovani nei processi decisionali — cercando di non ridurre la loro voce a una consultazione simbolica.
La sostenibilità, quindi, non è solo la cornice valoriale della VIG, ma anche il suo banco di prova. Perché questa riforma non si limiti a un gesto simbolico, occorre che diventi cultura politica: un metodo per misurare il tempo delle decisioni e restituire al futuro il peso che gli spetta. In questa prospettiva, la VIG può trasformarsi in una palestra di responsabilità condivisa, dove cittadini, istituzioni, associazioni collaborano per coniugare la competenza con la cura, l’efficienza con la giustizia, e il presente con il futuro.
L’intergenerazionalità come criterio etico
Il provvedimento sulla Valutazione d’Impatto Generazionale (VIG) assume una rilevanza particolare se analizzato attraverso la lente filosofica della responsabilità intergenerazionale, come delineata da Hans Jonas. Jonas propone un’etica della responsabilità rivolta non solo alla contemporaneità, ma soprattutto alle generazioni future, ponendo al centro della riflessione morale la conservazione della vita e delle condizioni necessarie per la sua prosecuzione.
Questo orientamento filosofico invita a riconoscere nella VIG uno strumento che, al di là delle implicazioni economiche e di sostenibilità, introduce una visione temporale allargata nel processo decisionale pubblico. La valutazione esplicita dell’impatto su più generazioni rappresenta un superamento della tradizionale prospettiva di breve periodo, tipica della politica e dell’economia odierna, ponendo l’accento su un principio di prudenza fondato proprio sulla tutela del “non ancora nato”.
Tuttavia, il dilemma che si pone rispetto all’effettività del provvedimento riguarda la traduzione di questa responsabilità etica in azioni concrete, sostenibili e vincolanti nel tempo. La sfida è duplice: da un lato, garantire che le future scelte politiche e economiche non compromettano irreversibilmente le risorse e le condizioni di vita delle generazioni a venire; dall’altro, evitare che la VIG rimanga una mera dichiarazione programmatica priva di efficaci strumenti di controllo e partecipazione.
In conclusione, il provvedimento segna un passo importante verso una nuova cultura giuridica e politica dell’intergenerazionalità, ma la sua portata trasformativa dipenderà dalla capacità dello Stato e della società civile di adottare un approccio integrato e multidisciplinare, che renda vera la responsabilità intergenerazionale evocata da Jonas. Soltanto in questo modo la VIG potrà diventare un autentico paradigma di governance sostenibile e inclusiva per il futuro.
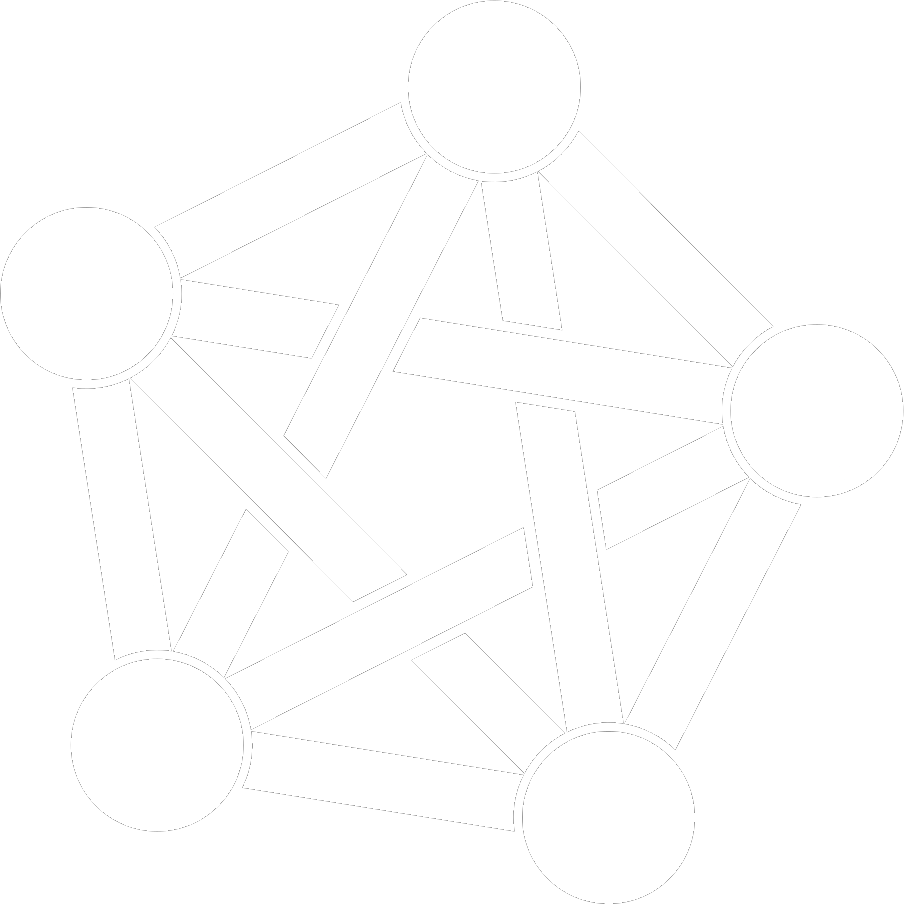
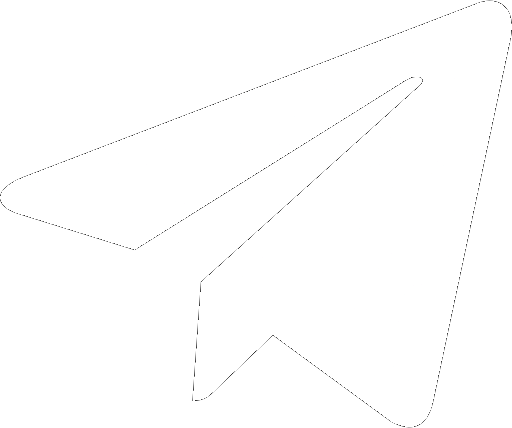




Scrivi un commento